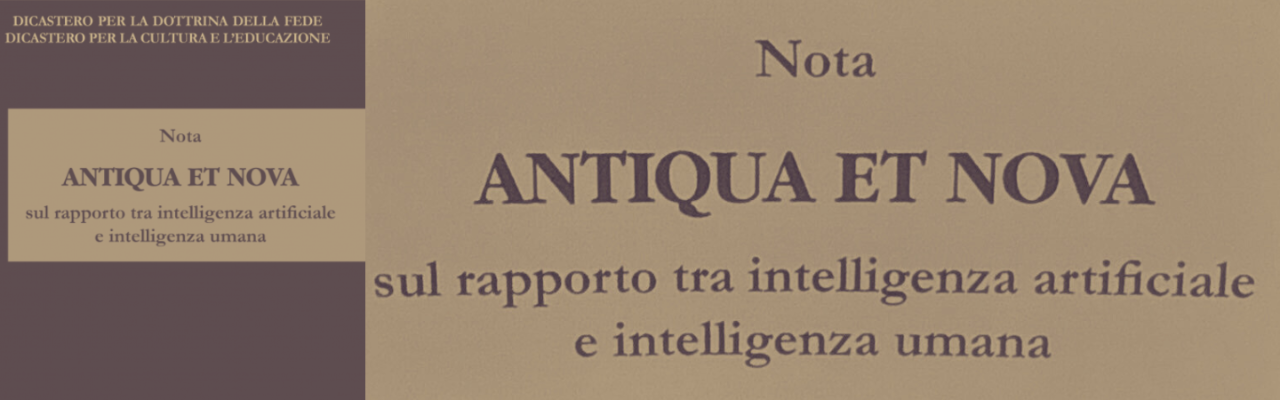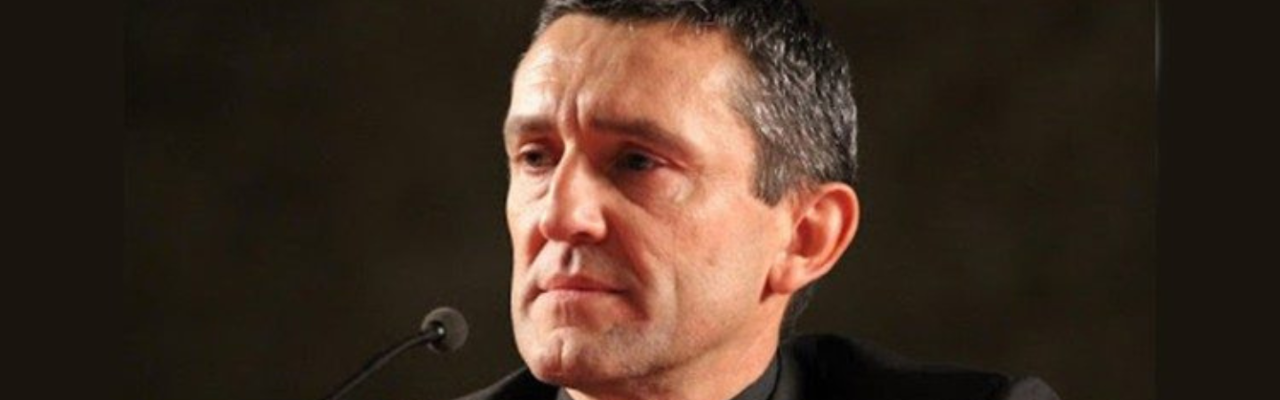Congresso africano sull'educazione cattolica
Intervento di Mons. Giovanni Cesare Pagazzi al Symposium International di Abidjan (Costa d'Avorio)
Introduzione
Il premio Nobel 1986 per la letteratura, lo scrittore nigeriano Wole Soyinka, ha affermato «Tutto è negoziabile anche l’unità nazionale, ma non il diritto delle persone a determinare il proprio futuro».
In questi ultimi anni si è parlato molto dell'Africa come il continente del futuro in quanto si trova in un rapido e continuo sviluppo. Un futuro che sarà l'Africa stessa a determinare, nonostante i tentativi delle potenze economiche di intervenire per imporre i propri trend di sviluppo.
Papa Francesco in occasione della ricezione del documento "African Education Pact" nel giugno scorso (2023) disse: "Guardiamo l'Africa con molta fiducia, perché ha tutto quanto le serve per essere un continente capace di tracciare i cammini futuri". Il Papa si riferisce non solo alle risorse minerarie, sviluppo economico e progressi nei processi di pace, ma soprattutto alle sue risorse educative.
Non c'è futuro senza educazione. Il futuro dell'Africa sta nella sua gioventù, è infatti il continente più giovane del mondo, i giovani sono la sua più grande ricchezza, per questo dovrà investire le energie migliori per la loro formazione. Si prevede che entro il 2050 la popolazione africana raddoppierà e per la fine di questo secolo gli africani saranno il 40% della popolazione mondiale. Va da sé che da come vengono educati ora i ragazzi e giovani africani, si potrà prevedere come sarà il futuro non solo dell'Africa, ma del mondo.
Il 19 settembre scorso (2023) l'osservatore permanente della Santa Sede presso le Nazioni Unite nel suo intervento al Meeting dal titolo: “Education: a catalytic investment for development. Providing youth with the freedom to build their future” (L'educazione: un investimento catalizzatore per lo sviluppo. Offrire ai giovani la libertà di costruire il proprio futuro) ha richiamato l’impegno comune di costruire il Villaggio dell’Educazione, ascoltando la voce dei giovani. Ha affermato: “Un errore che viene commesso spesso è quello di predisporre programmi educativi per i giovani pensati dagli adulti e a partire dalla prospettiva degli adulti, senza interrogarsi su cosa i giovani vogliono veramente per la loro educazione e per il loro futuro. 'Offrire ai giovani la libertà di costruire il proprio futuro' presuppone il loro ascolto: cosa potremmo offrire ai giovani se non sappiamo nemmeno cosa vogliono ricevere?”. E avanza la proposta del Papa di un'alleanza educativa di tutti coloro che operano nel mondo dell'educazione e della cultura, attraverso il progetto del Patto Educativo Globale con l’obiettivo di cambiare il mondo attraverso l'educazione.
Ascoltare le giovani generazioni vale anche e soprattutto a riguardo dei giovani africani: ascoltare la loro voce è ascoltare la voce di una grande porzione dell'umanità.
Anche il Rapporto della Commissione internazionale dell’UNESCO sui Futuri dell’Educazione dal titolo “Reimagining our Futures together: A new social Contract for Education” parla di futuro, o meglio di futuri al plurale, e riconosce all’educazione il potere di produrre un cambiamento profondo nel mondo grazie a un nuovo contratto sociale per l’educazione.
Africa continente del futuro (le ragioni di una speranza)
Senza voler passare acriticamente dall'afro-pessimismo a un afro-ottimismo ingiustificato, vogliamo evidenziare alcuni indicatori che giustificano la speranza in un futuro promettente per l'Africa.
1. L'enormità del suo territorio.
L’Africa si estende per 30 milioni di chilometri quadrati, dei quali solo una minima parte coltivati e irrigati e contiene il 65% delle risorse naturali mondiali (oro, petrolio, gas, fili, ferro, terre rare, ecc.). Un territorio immenso con enormi possibilità.
2. La grande popolazione giovanile in continua crescita.
L'età media degli africani è di 19,5 anni, il 50% degli africani ha meno di 25 anni e il 70% ha meno di 30 anni. Quindi una grande massa lavoro che potrà produrre una grande ricchezza. Ci troviamo di fronte a un esercito sterminato di giovani africani intraprendenti, definiti come appartenenti alla cheeta-generation (generazione ghepardo), che non si siedono a piangere sul passato segnato dalla colonizzazione e schiavitù, ma che lavorano, studiano e si sacrificano con dedizione per costruire il loro futuro e dei loro paesi. In Europa invece aumenta sempre più il numero degli appartenenti alla Hippotomamus-generation (generazione ippopotamo) che ad un certo punto non riuscirà più a tenere il passo della cheeta-generation.
3. L'economia in continua espansione.
Dal 2000, l'economia nel continente è cresciuta costantemente tra il 4 e il 7%, ed è seconda solo a quella del Sud-Est asiatico. Un macrotrend che non si può ignorare (anche se con la pandemia da Covid19 e con la guerra russo-ucraniana c'è stata una battuta d'arresto).
4. La diminuzione delle guerre e delle malattie e una maggiore urbanizzazione.
Negli ultimi 20 anni si è registrato un calo dei conflitti armati, fatto che fa ben sperare in un futuro migliore. L'urbanizzazione in Africa sta avvenendo al ritmo più veloce della storia umana. Nei prossimi decenni, un africano su due vivrà in città.
5. L'aumento dell'istruzione.
Dopo la decolonizzazione ci sono stati programmi di istruzione di massa e lo sradicamento dell'analfabetismo. Oggi l'Africa sta facendo passi da gigante nella qualificazione dell'istruzione. Vi è una proliferazione di istituti di istruzione superiore che formano personale più qualificato.
6. La diffusione della democrazia, dello Stato di diritto e della modernizzazione della società. L'Africa deve superare la diffidenza verso la democrazia: un maggiore sviluppo economico va di pari passo con una maggiore democratizzazione. C’è un affermarsi maggiore dello stato di diritto con la diffusione delle carte africane sui diritti degli uomini, dei popoli, delle donne, dei bambini e degli anziani, etc.
Per non cadere in un ottimismo ingenuo, vogliamo ricordare anche le criticità presenti e il persistere della violazione di alcuni diritti umani come:
- la libertà di coscienza: ci sono nazioni che hanno una "religione di Stato" e quindi vietano ai loro cittadini di scegliere liberamente.
- i diritti delle donne: in Africa esistono ancora tradizioni marcatamente sessiste e maschiliste che impongono riti e usanze che mettono in crisi la dignità della donna, come i riti di purificazione, la poligamia, l'infibulazione, ecc.
- i diritti delle minoranze: le minoranze politiche vengono spesso attaccate; le minoranze etniche sono vittime di discriminazioni razziali, xenofobia, etc.
⁃ i diritti dei bambini, degli anziani, dei detenuti, ecc. che spesso vengono ignorati e calpestati.
L'educazione in Africa.
In Africa esiste una solida tradizione educativa millenaria che ha formato gli africani per intere generazioni. Le figure educative più significative non sono rappresentate da pedagogisti o specialisti dell'educazione, ma da statisti, filosofi, missionari, persone carismatiche che hanno ispirato e fatto crescere intere nazioni.
Non esistono ancora delle “pedagogie africane” propriamente dette, intese come elaborazioni sistematica dell’educazione. L'elaborazione di pedagogie africane è un progetto in costruzione, e sarà il risultato di una riflessione originale ad opera degli stessi africani. Non si tratta di tradurre nelle lingue locali trattati di pedagogia pensati e prodotti in altri continenti, ma di cammini pensati e prodotti a partire dal contesto culturale africano. Si tratta di pensare a delle "pedagogie per le persone africane".
Il primo passo da fare per l'elaborazione di queste pedagogie africane dovrà essere quello dello studio delle antropologie africane per conoscere chi sono l'uomo e la donna che vogliamo educare; il secondo passo riguarda l'epistemologia per cercare i fondamenti scientifici che legittimano un tale discorso sull'educazione; il terzo passo è legato all'ontologia e cioè avere ben presente cos’è l’essere per la riflessione africana; il quarto passo è quello dell'assiologia ossia quali sono i valori ai quali si vuole educare le persone africane. Infine il quinto e ultimo passo, quello pedagogico, e cioè interrogarsi sui riferimenti pedagogici imprescindibili, tra i quali l'educazione tradizionale africana.
Sono convinto che la tradizione educativa africana e le pedagogie africane abbiano molto da contribuire e dare al sistema educativo mondiale.
Cinque passi per le "pedagogie africane"
1) Le Antropologie di riferimento.
Per l'elaborazione delle "pedagogie africane" è necessario avere chiara l'idea dell'uomo e della donna che vogliamo educare, quindi bisogna indagare qual è l'idea soggiacente di persona. La persona africana è tale se e solo se è aperta alle due dimensioni fondamentali della sua esistenza: la dimensione verticale, cioè il rapporto con l'Altro che si identifica con Dio, con gli spiriti, gli antenati, etc. e la dimensione orizzontale, cioè il rapporto con l'altro che si identifica con la comunità , la famiglia, la società, etc. Nell'educazione della persona africana è di fondamentale importanza considerare la dimensione trascendentale, in quanto, come disse il filosofo-teologo africano John Mbiti, la persona africana è ontologicamente religiosa.
Oltre a questa lettura antropologica, più legata agli aspetti culturali e identitari, c'è un'altra lettura più legata ai temi della povertà antropologica e del paradigma libertario. Anche se le due letture si completano a vicenda, la seconda è più legata al momento pratico. In questa corrente possiamo riconoscere vari teologi della liberazione africana e filosofi militanti per i quali la figura di uomo e donna che hanno presente non è quella di un concetto antropologico astratto, ma l'uomo e la donna africani concreti, oppressi, colonizzati, schiavizzati e oggi, anche dopo l'indipendenza dei paesi africani, l'uomo e la donna che ha bisogno di liberarsi concettualmente e politicamente. È l'uomo e la donna come soggetti storici capaci di liberazione, e non soggetti passivi.
2) Epistemologia
Le pedagogie e le filosofie dell'educazione in Africa risentono anch’esse dalla crisi epistemologica trasversale e mondiale che permea tutte le aree della conoscenza. Siamo in un'epoca di "crisi teoretica", conseguenza del nichilismo. I discorsi sull'educazione, così come i numerosi corsi di formazione o di aggiornamento per gli educatori (insegnanti) si limitano quasi esclusivamente al momento pratico e cioè a come incontrare soluzioni pratiche per la risoluzione immediata di problemi concreti. Esistono molti corsi di aggiornamento riguardanti la didattica, le metodologie di insegnamento, l’uso di mezzi informatici o audiovisivi nell'istruzione... ma queste formazioni trascurano le questioni fondamentali dell'educare: che cos'è l'educazione? Educare per cosa? Quali sono i fini dell’educazione? Solamente buone fondamenta teoriche possono produrre delle buone pratiche.
Un'epistemologia africana (e questo vale anche per tutte le “epistemologie del Sud” e non solo) esige una nuova idea di razionalità e un nuovo linguaggio. Esige una nuova idea di ragione in grado di superare i limiti angusti dell'Illuminismo e della razionalità positivista, per espandersi a una ragione allargata che possa includere tutte le razionalità sottostanti in ogni cultura e tradizione. Un nuovo linguaggio che superi il linguaggio ontologico troppo limitato, che incontri nel linguaggio simbolico uno strumento che possa dire molto di più del linguaggio strettamente razionale. Come possiamo vedere, è necessario superare un'epistemologia della semplicità che nella sua idea di totalità ha voluto riportare tutto all'unità (che è sempre coincisa con la visione occidentale), per abbracciare un'epistemologia della complessità, che rivendica non l’uniformità del reale ma la sua complessa poliedricità (Papa Francesco propone nella Evangelii Gaudium la figura del poliedro al posto della sfera). L'epistemologia della complessità potrebbe essere il fondamento teorico più pertinente per un'epistemologia africana e per tutte le epistemologie "contestuali".
3) Ontologia
Le "Pedagogie africane" dovranno fondarsi sull'ontologia africana.
Se l'idea di essere dell’ontologia occidentale è qualcosa di statico, unico, immutabile, l'idea di essere dell’ontologia africana è qualcosa di dinamico: l’essere è vita, è forza, è una forza vitale, è un'unione vitale, è ‘vitalogia’. Placide Tempels, tra gli iniziatori della filosofia africana contemporanea, scrisse che "La vera saggezza è il sapere ontologico". Egli delinea l'ontologia africana dove l'essere è concepito come "forza vitale". Da questa ontologia Tempels deduce l’antropologia, l’etica, la filosofia, la religione. Secondo noi dall'ontologia africana si deve evincere anche la pedagogia africana: se l'essere per l'ontologia africana è la Vita, allora formare è educare la persona africana alla vita, ai valori della vita. Educativo sarà tutto ciò che promuove la vita e rispetta la vita. Anti-educativo sarà tutto ciò che offende e diminuisce la vita.
4) Assiologia
Le pedagogie africane dovranno basarsi sui valori africani che vorranno insegnare. Senza assiologia non c'è pedagogia, perché la pedagogia vive di obiettivi, progetti (accompagna la politica, le ideologie, il potere sociale, ecc.). Ma come scegliere i valori in educazione? Privilegiando quelli che sono più in sintonia con le proprie antropologie e ontologia, che corrispondano alla propria vocazione di sapere/agire, in modo che non siano vuoti o utopici, e non contraddicano i diritti fondamentali dell'uomo .
Nel contesto africano, quali sono i valori che si vogliono trasmettere in educazione? Quali dovrebbero essere i criteri di discernimento per selezionare questi valori?
La risposta a queste domande implica l'avvio di quel processo di ricerca dell'autenticità africana che ha visto impegnata la riflessione di molti filosofi e pensatori africani in questi ultimi decenni i quali concordano nell’identificare i valori africani con quelli dell’ascolto, dell'incontro, dell’accoglienza e dell’ospitalità, della relazione con Dio, gli antenati, della famiglia, del clan e della terra stessa, della simpatia/empatia, della gioia e della festa, della speranza e del futuro, e molti altri che possiamo sintetizzare nella centralità della famiglia, nella profonda religiosità, nell’amore per la vita e la fecondità, nella venerazione degli anziani, nella solidarietà e ospitalità.
5) Pedagogie africane
Come è notorio, l'educazione in Africa non è iniziata con la colonizzazione, ma vanta una storia millenaria. Il colonialismo ha completamente ignorato l'esistenza di metodi educativi locali come se non esistesse nessun tipo di educazione prima dell'introduzione delle scuole europee. Questa concezione limitata di educazione occidentale si riduce all'educazione formale. In Africa c'è una millenaria educazione informale che ha forgiato generazioni e generazioni fornendo ai destinatari le basi per integrarsi nella società locale in particolare attraverso le scuole di iniziazione dove si imparano le leggi e i costumi tradizionali, le arti, l'artigianato e le tecniche agricole e venatorie, il canto e la danza. Con l'aumento della complessità della società, cresce anche la necessità di un'istruzione formale, per cui le pedagogie africane devono conciliare i valori moderni dell'era post-indipendenza con i valori dell'educazione tradizionale anteriori alla colonizzazione.
Il sistema educativo del colonizzatore era basato sulla scuola, mentre quello degli indigeni era basato sulla famiglia e sulla società ("per educare un bambino ci vuole un villaggio intero"). La sfida per le pedagogie africane sarà quella di conciliare i valori tradizionali con la modernità, quindi come educare la persona africana oggi di fronte alle sfide del terzo millennio? La soluzione di questo quesito sarà un apporto importante anche per l’educazione occidentale, quasi esclusivamente basata sul sistema scolastico.
Il Patto Educativo Globale
Quando Papa Francesco ha lanciato il progetto del Patto Educativo Globale, sono emerse fin da subito molte affinità con i valori dell'educazione tradizionale africana.
Innanzitutto il Papa lancia il progetto all'insegna di un proverbio della saggezza africana: "Per educare un bambino ci vuole un villaggio intero", e cioè dall'idea tipicamente africana di concepire l'educazione non come un'azione individuale ma comunitaria.
In Africa, come detto sopra, esiste un'antica tradizione educativa che precede l'invasione coloniale e l'insediamento di scuole europee sul suolo africano. Molti dei valori del GCE hanno un'affinità con i valori della cultura africana.
In Africa è sempre esistito un "tacito patto educativo" tra i membri della comunità. Nel villaggio africano, ogni donna e ogni uomo è madre e padre di tutti i bambini che vi abitano, e ognuno ha il compito di educare e accudire ogni bambino, anche se non è il proprio. Ogni uomo e ogni donna viene chiamato papà e mamma dai bambini africani. Secondo il proverbio africano citato sopra, è l'intero villaggio a educare il bambino, non solo i genitori o gli insegnanti.
Anche l'idea di fratellanza universale, su cui Papa Francesco insiste molto, è un valore ontologico che appartiene da sempre ai popoli e alle culture africane, condensato nell'aforisma "Io sono perché noi siamo, e poiché noi siamo, dunque io sono". Il Patto Educativo Globale quindi non è alieno a ciò che l'Africa ha sempre incarnato nella sua tradizione educativa.
L'Africa si trova ora ad affrontare la sfida della modernità.
Negli ultimi decenni, l'Africa ha assistito alla diffusione di nuove tecnologie. La rete di telefonia mobile si è espansa enormemente e ha permesso di raggiungere rapidamente e a basso costo distanze enormi che erano impossibili da raggiungere con la telefonia fissa. Collegata alla telefonia mobile, anche la rete Internet si è diffusa ampiamente, permettendo all'Africa di connettersi con il resto del mondo. Nel campo dell'istruzione, la rivoluzione digitale rappresenta una grande opportunità per l'Africa di collegare le proprie università con i centri di ricerca e le biblioteche digitali di tutto il mondo. Purtroppo, questa grande opportunità non viene ancora sfruttata pienamente, non solo perché le politiche educative non hanno ancora colto l'importanza di questi strumenti, ma anche perché non tutti i docenti e amministratori scolastici sono esperti nell'uso delle nuove tecnologie e non sfruttano questa grande opportunità come dovrebbero. Solo con la comparsa del coronavirus si è cominciato a rendersi conto dell'importanza dell'uso della tecnologia nel processo di insegnamento e apprendimento. In Africa, ci sono ancora diverse difficoltà da superare se si vuole che la rivoluzione digitale trasformi le università. Tra le varie difficoltà ritroviamo la mancanza di una rete internet più potente e accessibile a tutti a prezzi bassi; la disponibilità di computer e tablet a prezzi adeguati alla realtà economica africana; la formazione dei docenti all'uso delle piattaforme digitali; l'apprendimento dell'inglese nei paesi non anglofoni, visto che la maggior parte delle informazioni online sono in questa lingua, ecc.
Inoltre, bisogna far fronte al fenomeno del "digital divide" (sia geografico che interno), causato non solo dalla mancanza di infrastrutture e dai limiti economici, ma anche dall'analfabetismo informatico di cui abbiamo parlato in precedenza. In questo modo, la rivoluzione digitale, che dovrebbe diventare un'opportunità per lo sviluppo di tutti i popoli, si trasformerebbe in un ulteriore motivo di divisione e discriminazione tra i popoli e all'interno dei popoli (il cosiddetto "apartheid digitale"). L'Africa non può permettersi di perdere questa opportunità della rivoluzione digitale, per non correre il rischio di rimanere indietro e di essere tagliata fuori dal resto del mondo.
Uno dei temi ricorrenti nel dibattito africano degli ultimi decenni è stato il rapporto tra tradizione e modernità. La nuova identità da ricostruire deve essere in grado di conciliare la memoria (il passato, gli anziani, le radici) con l'utopia (il futuro, i giovani, le speranze). Come si è detto, anche se la vita moderna ha introdotto cambiamenti significativi nella cultura tradizionale, l'identità africana è ancora molto definita. Una domanda ricorrente nel dibattito attuale è: "Come essere autenticamente africani nel terzo millennio?".
Il GCE mira alla custodia della casa comune. Gli africani hanno sempre avuto una stretta relazione con la natura perché la loro vita dipende da essa (cibo, acqua, sole, animali, oceani e fiumi...) così pure la loro morte (malaria, inondazioni, cicloni, siccità, ecc...). L'Africa è un meraviglioso e immenso continente verde con ecosistemi diversi, flora e fauna uniche, ma questo patrimonio è spesso attaccato dallo sfruttamento selvaggio delle sue ricchezze naturali. Al di là degli ecologismi romantici che considerano l'Africa il giardino dell'Eden sulla terra, e al di là dei facili vittimismi che considerano l'Africa vittima di uno sfruttamento esterno da cui non sa come difendersi, l'Africa ha soprattutto bisogno di rafforzare l'educazione ecologica integrale per potenziare il suo rapporto sacro con la natura e di conseguenza il suo rapporto con l'umanità.
Il GCE mette al centro la persona nella sua dimensione necessariamente relazionale, capace di dialogo. Mettere al centro la persona non significa mettere al centro l'individuo, perché la persona, come si è detto, è tale se e solo se è in relazione con gli altri, è etero-referenziale, mentre l'individuo è avulso da ogni relazione con gli altri, è autoreferenziale. Notoriamente la cultura africana mette al centro la comunità, la famiglia, come sottolineano l'Ubuntuismo e il Bantuismo, ma non dobbiamo pensare che queste correnti escludano l'importanza della persona. Infatti, il famoso aforisma citato sopra "Io sono perché noi siamo, poiché noi siamo, dunque io sono" inizia con l'affermazione del sé "Io sono" che è tale perché in relazione agli altri "Noi siamo". La persona è tale se e solo se è in relazione con gli altri (comunità, famiglia, ecc.) e con Dio (antenati, spiriti, ecc.). Quindi, oltre a "sono perché siamo", dovremmo come ha ricordato il Papa nell’occasione del Patto Educativo Africano, aggiungere anche "perché credo e amo". Infatti, senza l'amore e la relazione con Dio e la comunità, non abbiamo la persona ma solo l’individuo.
Mettere al centro la persona significa mettere al centro la relazione. Una delle maggiori caratteristiche della personalità africana è il valore dell'ospitalità. L'accoglienza dell'altro rivela una visione dell'altro non come nemico, ma come vicino da accogliere e aiutare. Fin dall'infanzia, i bambini africani vengono educati dai genitori ad aprire la porta agli stranieri, ad accoglierli in casa offrendo acqua, cibo e ciò che è necessario. In altre parti del mondo invece (soprattutto in Occidente), si insegna ai bambini esattamente il contrario, a non aprire la porta a nessuno, a non parlare con chi non si conosce, a diffidare degli altri. Si tratta di visioni diverse. Ecco perché molti africani non capiscono perché quando vanno in altri Paesi nessuno apre loro la porta e vengono respinti. L'Africa può quindi dare un grande contributo per cambiare questa visione e aiutare le persone a pensare in modo diverso, vedendo l'altro non come un nemico o un avversario da combattere, ma come un fratello, un essere umano di pari dignità. L'Africa può insegnare al mondo come umanizzare le relazioni tra le persone.
La grande sfida per l'Africa
La grande sfida per l'Africa è quella di migliorare ancora di più la qualità dell'istruzione, perché sa che la sua grande ricchezza sono i giovani, e investire nei giovani significa investire nello sviluppo e nel futuro del continente stesso. Istruire oggi non è più sufficiente insegnare a leggere e scrivere. È necessario sviluppare le capacità di pensiero critico, l'uso delle nuove tecnologie, la comunicazione e la cooperazione, la creatività, l'imprenditorialità, ecc. La formazione degli insegnanti è quindi la priorità assoluta, perché dalla qualità dei formatori dipende la qualità dei discenti. La preoccupazione iniziale per la massificazione dell'istruzione deve ora evolversi in una preoccupazione per la sua qualificazione. La qualificazione dell'insegnamento non si limita al miglioramento dei contenuti tecnico-scientifici, ma si estende anche al miglioramento della qualità dell'insegnamento, alle relazioni tra insegnanti e studenti. Un'istruzione di qualità è un bene che deve essere accessibile a tutti, proprio come un vaccino contro un virus deve essere disponibile per tutti. Un'istruzione di qualità alla portata di tutti è possibile. L'Africa non ha le risorse per costruire infrastrutture gigantesche come enormi campus universitari o grandi biblioteche con milioni di libri, ma può costruire edifici più modesti e ugualmente funzionali, investire in biblioteche digitali. I costi saranno inferiori e i risultati maggiori perché la ricerca fatta attraverso le risorse digitali è più veloce, più completa e più facile da condividere.
L'idea di istruzione trasmessa dalle grandi università del mondo, dove gli studenti spendono decine e decine di migliaia di dollari per la loro formazione, è quella che l'istruzione di qualità sia qualcosa di elitario, solo per pochi privilegiati, alimentando così l'idea che le differenze nel mondo sono qualcosa di naturale: i ricchi, i privilegiati possono fare e avere tutto ciò che vogliono, mentre i poveri non possono fare nulla. Un'istruzione di qualità, invece, può e deve essere per tutti e non solo per una minoranza.
L'Africa insegna al mondo che i beni che abbiamo a disposizione devono essere condivisi con tutti, che non possiamo essere autenticamente uomini e donne da soli o beneficiare di qualcosa senza aiutare gli altri. Anche la morale cristiana insegna che chi possiede, possiede per condividere.
Come in un villaggio africano tutti gli uomini e le donne sanno che devono prendersi cura di tutti i bambini del villaggio, anche dei figli degli altri, così tutti gli uomini e le donne della terra dovrebbero avere la stessa preoccupazione per tutti i bambini e i giovani del mondo.
Il più grande contributo che l'Africa può dare alla costruzione del Villaggio educativo globale sarà quello di trasmettere al mondo il più grande principio educativo della propria tradizione: ogni uomo è padre e ogni donna è madre di tutti i bambini e giovani della terra.
Conclusione
Nel discorso in occasione della consegna del Patto Educativo Africano Papa Francesco ha ricordato un altro proverbio africano: "Quando le radici sono profonde, non c'è motivo di temere il vento". L’osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU nell'incontro alle Nazioni Unite nel settembre scorso, ha concluso il suo discorso citando un altro proverbio africano: "Se vuoi andare veloce vai da solo; se vuoi andare lontano, vai insieme".
Come vediamo, la saggezza dell'educazione tradizionale africana ha molto da insegnare al mondo di oggi, e il mondo dovrebbe essere più attendo a questo insegnamento.
Purtroppo l'occidente è stato fortemente condizionato da "maestri" che per secoli hanno insegnato la differenza tra le razze e la conseguente gerarchizzazione che metteva all'ultimo posto quella africana. Questi "cattivi maestri" sono stati nientemeno che i più illustri filosofi dell'Illuminismo (Kant, Hegel, Voltaire, Hume, Montesquieu, etc.) che sono alla base del cosiddetto razzismo scientifico: "Quasi tutti i maggiori filosofi dell'Illuminismo, così celebrato per l'esaltazione della libertà e dei diritti, furono in effetti i peggiori teorici del razzismo moderno e contemporaneo nei confronti delle popolazioni negroafricane" (Filomeno Lopes). Le teorie del razzismo scientifico, ma che sarebbe meglio definire "pseudoscientifico", sono state ampiamente smentite in seguito dalla comunità scientifica perché le basi su cui poggiavano erano spesso infondate, distorte o addirittura inventate in quanto la genetica moderna ha dimostrato che non esistono basi biologiche o genetiche per giustificare l'idea di razze superiori o inferiori. Per questo è necessario conoscere a fondo la questione, prendere coscienza della realtà per smascherare i costrutti ideologici che hanno fatto da supporto all'ideologia razzista. Dopo la decostruzione delle ideologie pseudoscientifiche dei "cattivi maestri" che loro malgrado hanno insegnato a discriminare e quindi ad odiare, dobbiamo aprire lo sguardo al futuro, per imparare a rispettare e riconoscere la dignità di ciascuno. Questi pregiudizi, che hanno marcato in modo devastante i rapporti tra i popoli sono duri a morire, e potranno essere superati solo attraverso una nuova educazione liberatrice che insegni la fraternità e l'uguaglianza tra tutti gli uomini. È propriamente questo che Papa Francesco propone con il suo visionario progetto del Patto Educativo Globale, dove lancia la sfida di cambiare il mondo attraverso l'educazione.
L'Africa con la sua cultura millenaria ha molto da insegnare al resto del mondo. E non è un caso che sia stato il primo continente a produrre un Patto Educativo continentale. Ancora una volta l’Africa è un esempio da seguire, come ha detto Papa Francesco: "Mi auguro che il Patto Educativo Africano sia seguito anche dagli altri continenti".
È quello che ci auguriamo anche tutti noi.