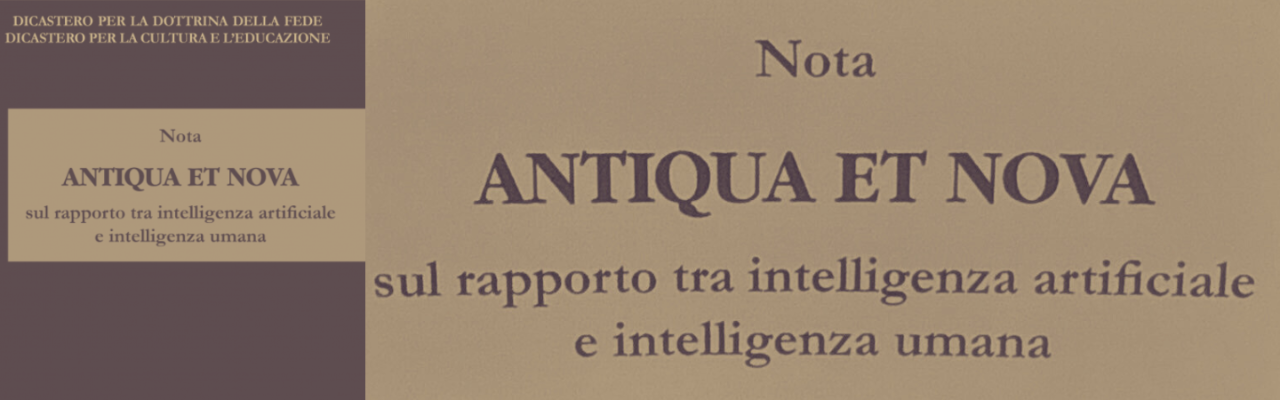Centenario della Facoltà cattolica di Teologia rimasta all’interno dell’Università di Strasburgo
L’accordo con il Vaticano. Un'eccezione destinata a durare.
Vostra Eccellenza Monsignor Philippe Ballot, Amministratore della Diocesi di Strasburgo,
Ambasciatore Jean-Christophe Paucelle, Consigliere per gli Affari Religiosi presso il Ministero degli Affari Esteri e dello Sviluppo Internazionale,
Michel Deneken, Presidente dell’Università di Strasburgo,
Rettori e Vice-Rettori,
Marc Feix, Decano della Facoltà di Teologia,
Decani di Facoltà,
Illustri Professori,
Cari studenti, colleghi e ospiti d’onore,
sono lieto di essere qui con voi in questa occasione. Desidero esprimere la mia personale gratitudine e quella del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, non solo per l’invito ma anche e soprattutto per il vostro lavoro al servizio dell’insegnamento e della ricerca in campo teologico. Sono grato al decano della Facoltà di Teologia, Marc Feix, per avermi invitato a partecipare alla commemorazione del centenario della Facoltà cattolica di Teologia rimasta all’interno dell’Università di Strasburgo.
Papa Giovanni Paolo II ha detto che l’Università è “un centro incomparabile di creatività e di diffusione della conoscenza per il bene dell’umanità”. In realtà, il ruolo dell’Università non si limita alla trasmissione del sapere; essa è soprattutto impegnata nella ricerca della verità che rende libero l’uomo (cfr. Gv 8,32). Come ricordava la filosofa Simone Weil, “il bisogno di verità è più sacro di ogni altro” e “non c’è possibilità di soddisfare il bisogno di verità di un popolo se non si trovano uomini che amano la verità a questo scopo”. La vocazione dell’università è quella di rispondere a questa ineludibile esigenza di essere un laboratorio per la ricerca libera e disinteressata, ma allo stesso tempo rigorosa e sistematica, della verità. Infatti, nelle diverse scienze, forme di conoscenza e aspetti, la posta in gioco è sempre la costruzione di una competenza ad amare la verità, a restarle creativamente vicina, a codificarla e a condividerla. Solo così l’università può mettersi al servizio della persona umana e del bene comune. Giovanni Paolo II ha insistito su questo punto nella sua riflessione sul ruolo dell’università, sostenendo che “la nostra epoca ha urgente bisogno di questa forma di servizio disinteressato che consiste nel proclamare il significato della verità, un valore fondamentale senza il quale la libertà, la giustizia e la dignità dell’uomo sono soffocate”. La scuola non è il luogo in cui si esibisce il trionfo di una tecnica, ma il luogo in cui si costruisce l’umanesimo.
Il posto della teologia nelle università
Come ben sapete, in uno spirito di collaborazione, fu concluso un concordato tra l’Impero tedesco di Guglielmo II e la Santa Sede, per la fondazione della Facoltà cattolica di teologia. La Convenzione conclusa nel 1902 sotto Leone XIII fu applicata dal suo immediato successore Pio X con il breve Cum venerabilis del 1903, che riconosceva la canonicità dei diplomi. Dopo la Prima guerra mondiale, il destino della Facoltà di Teologia dell’Università di Strasburgo rimase incerto. Fortunatamente Alexandre Millerand, Commissario Generale della Repubblica, optò per il mantenimento della Facoltà e collaborò con Mons. Victor Martin, Decano dal 1923 al 1945, per ottenere il pieno riconoscimento della Convenzione del 1902. È così che lo scambio di lettere del 10, 16 e 17 novembre 1923 tra Mons. Bonaventura Cerretti, Nunzio Apostolico in Francia, e Mons. Raymond Poincaré, Presidente del Consiglio, ha portato alla riapertura dell’attuale Facoltà di Teologia Cattolica dell’Università di Strasburgo.
La presenza della Facoltà di Teologia della Cattolica all’interno di questa Università è il segno che il dialogo tra fede e ragione è possibile, necessario e fruttuoso. La riflessione teologica, infatti, non è un ostacolo ma un mezzo favorevole alla ricerca; essa rappresenta uno stimolo per il sistema scientifico a riconoscere, in un’epoca minacciata dalla frammentazione del sapere e dalla polarizzazione sociale, che tutto è interconnesso. Questo messaggio viene ribadito nella profetica enciclica Laudato si’, dove Papa Francesco afferma: “Non è superfluo insistere sul fatto che tutto è interconnesso. Il tempo e lo spazio non sono indipendenti l’uno dall’altro... Come le diverse componenti del pianeta – fisiche, chimiche e biologiche – sono interconnesse, così le specie viventi formano una rete che non abbiamo ancora finito di identificare e comprendere... Ecco perché la conoscenza frammentaria e isolata può diventare una forma di ignoranza se rifiuta di essere integrata in una visione più ampia della realtà”. L’inserimento della teologia nel contesto universitario deve essere visto in questo quadro e come garanzia di questo allargamento.
La teologia occupa quindi un posto legittimo all’interno dell’Università, accanto alle altre discipline. Come le altre discipline, gode di legittima autonomia e libertà in base alle proprie competenze, principi e metodi. Può quindi sviluppare e comunicare il significato della Rivelazione, facendo luce sulle questioni poste dalla cultura odierna. Certo, ogni disciplina conserva i propri metodi, ma l’interdisciplinarità offre una visione organica della realtà, accrescendone l’intelligenza e sviluppandone la comprensione. In questo modo, anche la teologia si apre, e da parte sua deve aprirsi, a domande sempre più ampie e correlate, pur rimanendo fedele a sé stessa.
Una teologia che guarda al futuro
Tuttavia, è importante che la celebrazione del centenario non solo ci permetta di guardare al passato con gratitudine, ma anche di guardare al futuro con coraggio. Lo stesso Papa Francesco ne parla nella sua Lettera apostolica “Ad theologiam promovendam” di questo mese di novembre, quando afferma: “Promuovere la teologia nel futuro non può limitarsi a riprodurre astrattamente formule e schemi del passato” (Ad theologiam promovendam, n. 1). È vero che oggi, su tanti fronti, c’è una sfida al rinnovamento della teologia che non può essere ignorata. È facile diagnosticare una certa stanchezza, o impasse, nella produzione teologica. Il campo di circolazione della teologia è stato culturalmente ridotto, anche se rimane una chiave decisiva per comprendere la persona umana e le nostre società. Il contributo scientifico della teologia al sistema della conoscenza non è ancora sufficientemente valorizzato, e questo non è sempre colpa di altri. La teologia stessa soffre spesso di autoreferenzialità, ripiegandosi su sé stessa in un monologo disciplinare che la impoverisce. Diventa tautologica, accontentandosi di essere la teologia della teologia o di storicizzarsi come un glorioso museo del pensiero.
Invece di questo sterile confinamento, Papa Francesco raccomanda un programma audace per la teologia. Scrive: “La riflessione teologica è chiamata a una svolta, a un cambio di paradigma” (Ad theologiam promovendam, n. 4) e, di fronte alle profonde trasformazioni culturali del presente, deve diventare più “consapevole che quella che stiamo vivendo non è semplicemente un’epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d’epoca” (Ad theologiam promovendam, n. 1).
Il Papa indica due strade da riscoprire. La prima si basa sul dialogo con il contesto. In altre parole, la teologia deve diventare “capace di leggere e interpretare il Vangelo nelle condizioni in cui gli uomini e le donne vivono la loro vita quotidiana”. Deve essere una scienza che si sviluppa non solo in modo deduttivo, ma anche “con un metodo induttivo [...], lasciandosi seriamente interrogare dalla realtà” (Ad theologiam promovendam, 8). Una teologia competente nell’arte del dialogo. Una teologia sinodale, intesa soprattutto come esercizio polifonico della parola e della comunione. Una teologia che abiti l’arena pubblica in modo credibile, qualificandosi per la sua capacità di entrare nella vita quotidiana, senza complessi di superiorità o di inferiorità.
Esporsi a questa alterità significa certamente aprire nuove vie di comunicazione e di collaborazione con i nostri contemporanei. Ma significa anche aprire nuove vie per rivelare Dio stesso in questo momento storico.
In questo atteggiamento di dialogo, la voce della teologia potrebbe essere essenzialmente interrogativa. Perché Dio è anche una domanda per noi. In questo modo, essa assolverebbe parte della sua funzione classica di critica profetica di ogni stagnazione e idolatria. Ma in modo ancora più decisivo, troverebbe il suo posto nel nostro tempo: come camera di riverbero per le domande fondamentali dell’umanità. La sua missione sarebbe allora quella di mantenere vive le domande che ci costituiscono come esseri umani e ci determinano come civiltà: cioè le domande su Dio, sull’uomo, sull’origine, sul senso, sulla fine, sul tempo, sul cammino, sulla sofferenza, sulla gioia, sull’appartenenza, sulla speranza, sul male, sulla felicità, sulla bellezza, sulla giustizia, sull’amore, sulla vita e sulla morte. La teologia funzionerebbe come sacramento della domanda, dando una presenza reale alle grandi questioni e permettendo a tutti di affrontarle.
Non è un caso che la seconda direzione che Papa Francesco invita la teologia contemporanea a prendere sia quella della sapienza. Perché “in questo modo la teologia può contribuire all’attuale dibattito sul “ripensamento” del pensiero, dimostrando di essere veramente un sapere critico come sapere sapienziale, non astratto e ideologico, ma spirituale” (Ad theologiam promovendam, n. 7). Le crisi e i bivi che le nostre società stanno drammaticamente vivendo dimostrano che non possiamo basare un’autentica costruzione su un unico modo di pensare o delegare il futuro dell’umanità alla tecnologia, dandole un assegno in bianco. Occorre ripensare i modelli dominanti di ragione e di pensiero, e soprattutto renderli più poliedrici e integrativi, realizzando la massima di Terenzio, tanto cara al vero spirito dell’università, secondo cui “io sono un uomo e nulla di umano mi è estraneo”.
Desidero porgere i miei migliori auguri alla Facoltà di Teologia e all’Università statale di Strasburgo. Che la vitalità della Facoltà nell’insegnamento, nella ricerca e nel servizio al bene comune possa continuare a crescere.
Sarei negligente se non concludessi senza riconoscere il lavoro prezioso e molto apprezzato che i professori svolgono all’interno della Facoltà e senza congratularmi con loro, incoraggiandoli a continuare i loro sforzi nella condivisione del sapere e nella ricerca teologica. Lo stesso vale per gli studenti che sono il suo presente e il suo futuro, così come per il personale, gli amici e tutti coloro che compongono quotidianamente la comunità universitaria. Congratulazioni a tutti voi.
Grazie.
______________________________
1. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae, n. 1.
2. Simone WEIL, L’enracinement in Oeuvres (Paris: Gallimard, 1999), 1049 ;1051.
3. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione apostolica Ex Corde Ecclesiae, n. 4.
4. FRANCESCO, Lettera enciclica Laudato si’, n. 138.
5. Cf. Ibidem, n° 29.
6. Cf. Ibidem, n° 20.