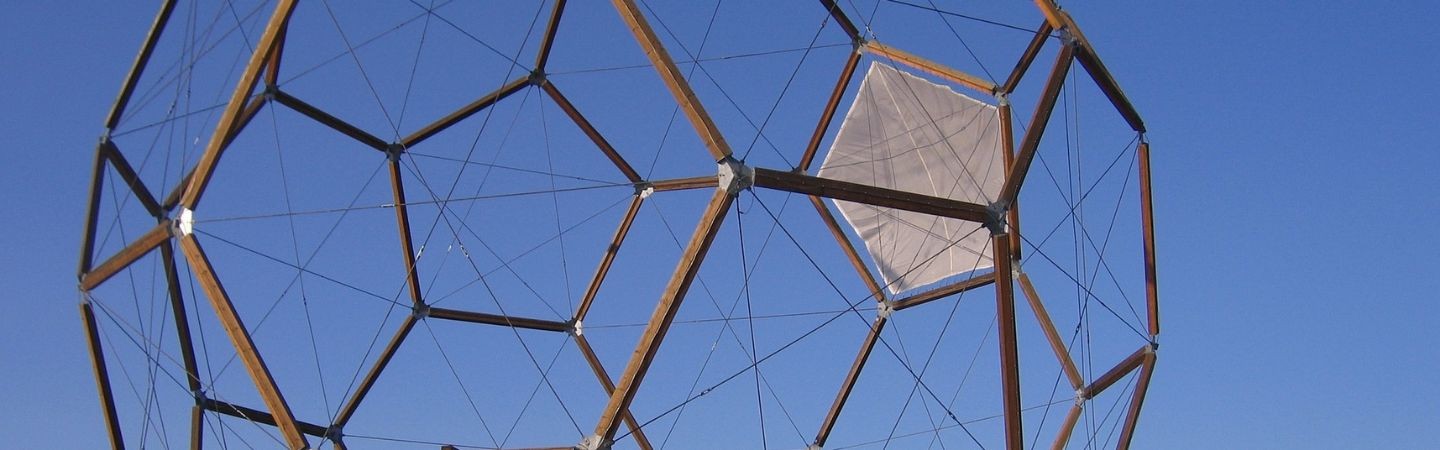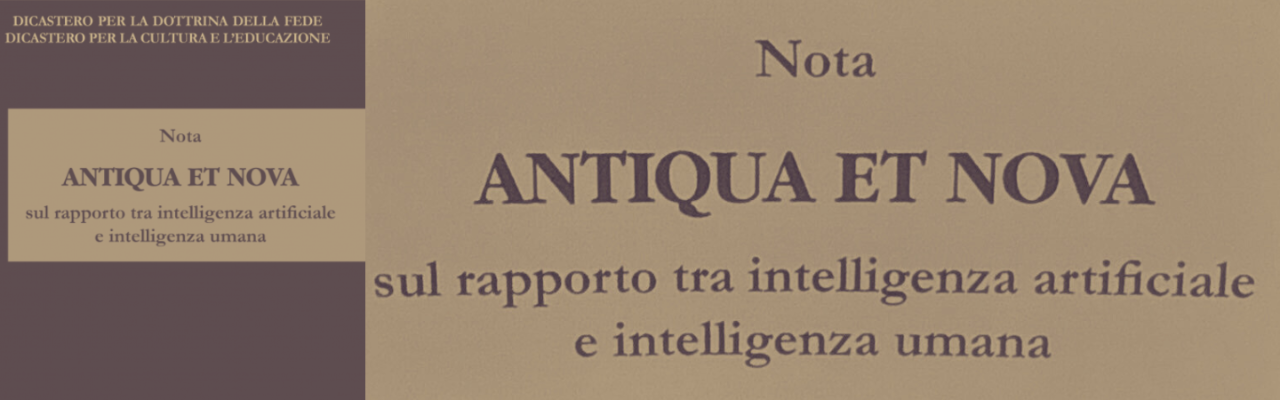Prefazione alla rivista KulturDiakonie
Più di cinquant'anni fa il controverso intellettuale italiano, Pier Paolo Pasolini, riflettendo sull'idea di cultura, con spietata lucidità affermava: «Noi intellettuali tendiamo sempre a identificare la “cultura” con la nostra cultura: quindi la morale con la nostra morale e l'ideologia con la nostra ideologia. Ciò significa che esprimiamo, con questo, un certo insopprimibile razzismo verso coloro che vivono, appunto, un'altra cultura».
Recentemente, altri intellettuali hanno messo in evidenza il binomio cultura-xenofobia, mostrando come in alcuni ambienti certi termini siano stati sostituiti con il vocabolo più neutro "cultura", malcelando il sotteso intento discriminatorio. Non potendo oggigiorno parlare di "differenza razziale", perché si verrebbe sommersi dalle accuse di xenofobia, si parla di "differenza culturale", non allo scopo di affermare la pluralità e la ricchezza della diversità, ma per tracciare confini discriminatori tra le persone: questa è la mia cultura, la mia tradizione che è diversa dalla tua. Il passaggio quindi alla gerarchizzazione delle culture, come antidoto al presunto relativismo, è molto breve.
Papa Francesco nel suo magistero ha più volte ribadito l'uguale dignità di ogni cultura e la ricchezza della diversità simboleggiata nella figura del poliedro (Evangelii Gaudium) e ha illustrato con chiarezza la dialettica tra il locale e l'universale (Fratelli Tutti 142-149): «L’universale non dev’essere il dominio omogeneo, uniforme e standardizzato di un’unica forma culturale imperante, che alla fine perderà i colori del poliedro e risulterà disgustosa» (FT 144). Tutta l'enciclica Fratelli tutti è un inno alla ricchezza della diversità e dell'uguaglianza (siamo tutti fratelli).
Il binomio cultura-razzismo può essere spezzato e sostituito dal binomio cultura-diaconia inteso in un duplice senso: della cultura che si pone a servizio della promozione umana di tutti, con un'attenzione speciale verso i più bisognosi, e dall'altra, della diaconia come impegno culturale, ossia come cura della Chiesa nei confronti della promozione della cultura, della sua tutela, della salvaguardia del suo patrimonio e del riscatto della tradizione culturale di ogni popolo.
Le nuove esigenze pastorali ci obbligano oggi ad ampliare questo senso diaconale, facendolo emigrare da una "visione caritativa" a una "visione culturale", verificando in che modo la diaconia amplia il significato di cultura e la cultura amplia quello della diaconia. Più concretamente, pensare una cultura a partire dalla diaconia implica vedere la cultura non come un patrimonio elitista o un argomento a favore di certe ideologie radicali, ma una cultura "al servizio" dell'umanità: una cultura che è capace di tradurre i desideri dell'umano (GS 1), di mettere in discussione certi sistemi politici e scalzare il conformismo sociale contro tutti i tentativi di disumanizzazione dell’umano (FT 115).
In senso inverso, pensare la diaconia a partire dalla cultura è espanderla a tutte le forme culturali, per una cultura più inclusiva e universale. La diaconia destabilizza la "tentazione di fare una cultura dei muri" (FT 27), a favore di una "cultura dell'incontro" (FT 30). Perché nessuno si salva da solo, e la salvezza dell'altro è anche una mia responsabilità.
Dal binomio cultura-diaconia consegue un altro binomio indissolubile che è quello di cultura-educazione: la cultura dell'incontro, della fratellanza universale, della pace può avvenire attraverso progetti educativi precisi. Affinché ci sia un cambiamento del mondo, ha ribadito più volte Papa Francesco, è necessario che cambi l'educazione. A tal fine il progetto del Patto Educativo Globale, che ha come scopo l'educazione di tutti alla fratellanza universale, traccia dei percorsi "obbligatori" che passano attraverso l'affermazione della centralità della persona, dei giovani, della donna, della famiglia, dell'altro, della società e dell'ambiente.
Anche la recente decisione del Pontefice di unire il Pontificio Consiglio della Cultura e la Congregazione per l'Educazione Cattolica in un unico Dicastero per la Cultura e l'Educazione, conferma l'inscindibilità del binomio cultura-educazione.
Un altro binomio che a nostro parere procede, o meglio precede i due precedenti, è quello cultura-razionalità. Nel nostro contesto culturale marcato, tra le varie crisi, anche da quella della razionalità, il servizio diaconale della cultura deve consistere nel riportare l'uomo alla ragione. Lungo il corso della storia la Chiesa si è trovata più volte a dover svolgere il ruolo di difensore della razionalità di fronte ai vari tentativi di de-ellenizzazione della fede, come ha ricordato magistralmente Benedetto XVI nel suo famoso discorso di Ratisbona. Anche Habermas nel dialogo del 2000 con l'allora Cardinal Ratzinger, aveva riconosciuto che «uno scetticismo radicale nei confronti della ragione è certamente originariamente estraneo alla tradizione cattolica».
Una cultura che non sia razionale, e quindi irrazionale, non può essere cultura. Per questo è necessario recuperare l'idea di razionalità allargata che soggiace ad ogni cultura. Ogni cultura infatti possiede la sua razionalità che dev'essere salvaguardata e valorizzata, contrariamente a quanto spesso si è fatto in passato nelle evangelizzazioni forzate che hanno fatto tabula rasa delle culture locali. Nel suo recente discorso in occasione della consegna del "Patto Educativo Africano" da parte di una delegazione di quel continente, il Papa ha ricordato che: «Il cristianesimo si sposa con la parte migliore di ogni cultura e aiuta a purificare ciò che non è autenticamente umano, e quindi neppure divino».
L'invito a tutte le culture ad aprirsi alla "vastità" della ragione, che Benedetto XVI a Ratisbona aveva lanciato come il grande compito dell'università, è il compito che si allarga a una diaconia culturale che vigili, da una parte, sulla razionalità di ogni cultura, e, dall'altra, sulla razionalità della ragione, in quanto molte idee di ragione dell'era moderna e contemporanea sono in realtà irrazionali. Il compito di una diaconia culturale sarà quello di risvegliare il mondo alla ragione e rilanciare un pensiero forte che consideri la verità come condizione della libertà, perché un "pensiero debole" non potrà mai avere accesso alle ragioni della libertà.
La diaconia culturale avrà la missione di ricordare all’uomo la bellezza che gli appartiene da sempre: Dio non solo è il sommo della ragione, in quanto Logos che è in principio di tutto, ma è anche il sommo della bellezza, e se l'uomo che Lui ha creato è "molto bello" è perché lo ha fatto a sua immagine e somiglianza.