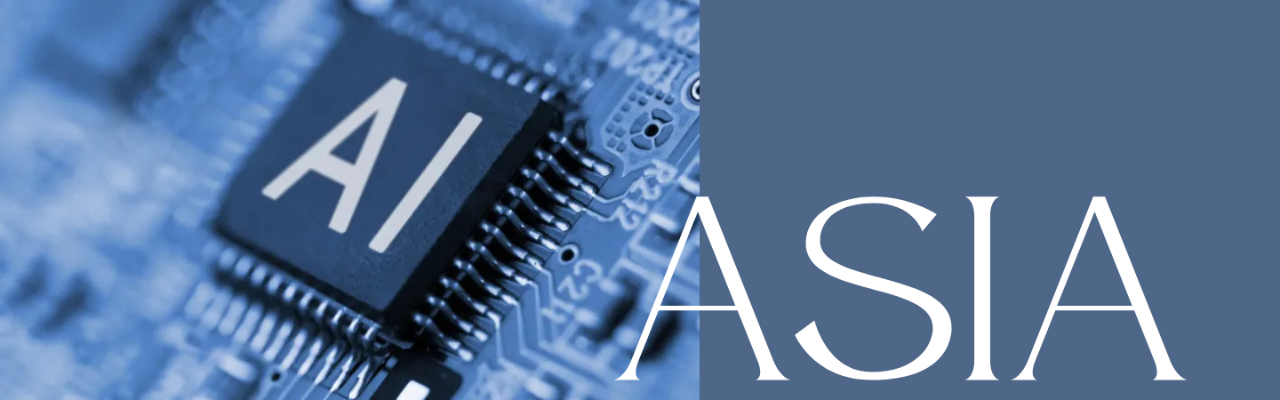La lettura è un esercizio spirituale
di Antonio Spadaro S.I.
Nella lettura si crea una relazione forte tra lettore e libro, nella quale il lettore non domina le pagine, ma piuttosto vi si muove all’interno e, mentre legge, legge sé stesso. Gianni Vattimo, sulla scia di Heidegger, ha riconosciuto nella tradizione della lettura biblica l’attestazione della possibilità di un tipo di lettura di un’opera letteraria, che non pretende di appropriarsi del suo oggetto, ma accetta di muoversi al suo interno, scoprendo un “mondo” di significati e risonanze. Aprire la Bibbia non ha mai significato solamente aprire un oggetto-libro: la lectio divina della tradizione occidentale legata al testo sacro considera questo come un mondo nel quale “abitare”. E la lettura biblica, nel suo sviluppo storico, ha offerto un modello di lettura dell’opera letteraria. Il testo legge il suo lettore.
Immagine di questa dinamica di lettura sono quelle miniature del XII secolo che presentano figure particolarmente luminose: se accostate a una candela, esse acquistano una radiosità propria. Queste miniature che accompagnano i testi sacri sembrano riprendere la tradizione dell’icona orientale: il pittore non dipinge la luce che colpisce l’oggetto e che poi è riflessa, ma dipinge esseri che hanno in sé una sorgente di luce: la luce è immanente nella pagina.
Ugo di San Vittore nel suo Didascalicon parla di una luce che illumina il lettore, ed evidentemente si riferisce a questa luminosità della pagina che rende il libro una medicina per l’occhio perché permette al lettore, mediante lo studium, di esporsi alla luce della pagina in modo tale che il lettore possa entrare nella luce di questo mondo e, all’interno di questo, riconoscersi e prendere coscienza di sé.
Questa esperienza secolare ha generato – tra l’altro – gli Esercizi spirituali di Ignazio di Loyola, il fondatore dei gesuiti. Essi non sono un testo da leggere, ma sono modi di meditare anche con l’immaginazione. Chi si esercita viene invitato a immergersi nel testo biblico in almeno tre modi: proiettando con l’immaginazione il proprio corpo nella scena rappresentata; partecipando alle emozioni dei personaggi; rivivendo, passo passo, le vicende del mistero contemplato. Si nota così come ogni esperienza spirituale sia associata a un elemento costitutivo della grammatica di una narrazione: ambientazione, personaggio e intreccio.
Per fare gli Esercizi non bisogna dunque semplicemente «leggere» il libro ignaziano, ma occorre eseguire le indicazioni che esso offre: guardare, sentire, ma anche toccare. L’esercitante è chiamato a entrare in un vero e proprio ambiente virtuale, che Ignazio chiama «composizione vedendo il luogo», e che è una vera e propria visione stereoscopica totale. Facciamo un paragone: giocare a un videogame generalmente significa muovere un protagonista attraverso tutti gli ambienti, i livelli del gioco, mediante la pressione di pulsanti e di un cursore o manopola: esiste sì un’interazione, ma la distanza tra reale e virtuale rimane netta. Negli Esercizi, al contrario, non è prevista una separazione tra lo spettatore-attore (il giocatore) e lo spazio virtuale visualizzato nello schermo: l’esercitante è chiamato a immergersi nella realtà contemplata, e a interagire pienamente con essa senza filtri. Gli Esercizi rappresentano una prefigurazione di molti dei temi sviluppati dalla tecnologia della realtà virtuale.
La letteralità del testo scritto richiede di essere infranta. La “verità” dell’esperienza dell’esercitante si trova non nella pagina scritta, ma nell’effetto che produce. Il “lettore” dunque, appare in una posizione di vero “autore” degli Esercizi che fa. In questa prospettiva leggere un libro non può che voler dire leggersi in esso: ognuno scrive il suo testo personale, direbbe Roland Barthes.
Per questo Ignazio non si ferma a raccontare storie con la ricchezza delle immagini e del linguaggio. Al contrario, le sintetizza in poche battute, cioè in tre “punti”, che aprono alla visione personale. Il lettore – come ben ha intuito Italo Calvino nelle sue Lezioni americane – ha il compito di «dipingere lui stesso sulle pareti della sua mente degli affreschi gremiti di figure, partendo dalle sollecitazioni che la sua immaginazione visiva riesce a estrarre da un enunciato teologico o da un laconico versetto dei Vangeli». La scrittura di Ignazio non tende a esaurire. Essa è affilata, precisa, ma secca, asciutta, capace più di evocare che di definire ed esaurire la possibilità di immaginare.
Il fine degli Esercizi non è di produrre una conoscenza più esatta della storia di Gesù, ma il coinvolgimento pieno del lettore in quella storia. Molto dunque dev’essere lasciato alla libera ricostruzione creativa. Ed è così che l’esperienza ignaziana diventa metodo che apre e abilita alla scrittura creativa. Lo aveva compreso perfettamente Marguerite Yourcenar, la quale nel suo taccuino di appunti scriveva, a proposito del suo capolavoro Memorie di Adriano, ambientato nel II secolo d.C.: «Le regole del gioco: imparare tutto, leggere tutto, informarsi di tutto e, al tempo stesso, applicare al proprio fine gli esercizi di Ignazio di Loyola». Questo metodo si condensa nell’espressione: «come se mi trovassi lì presente». E infatti prosegue la Yourcenar: «Perseguire l’attualità dei fatti, cercare di rendere a quei volti la loro mobilità, l’agilità della cosa viva». E anche «eliminare finché è possibile tutte le idee, i sentimenti che si sono accumulati, strato su strato, tra quegli esseri e noi». Il linguaggio della narrativa è, in questo senso, il linguaggio dell’esperienza diretta.
Ha commentato in maniera pertinente Italo Calvino: «L’idea che il Dio di Mosè non tollerasse d’essere rappresentato in immagine sembra non sfiorare mai Ignacio de Loyola. Al contrario, si direbbe che egli rivendichi per ogni cristiano la grandiosa dote visionaria di Dante e di Michelangelo senza neppure il freno che Dante si sente in dovere di mettere alla propria immaginazione figurale di fronte alle supreme visioni celesti del Paradiso». Ogni lettura così è chiamata a essere una performance.
Originariamente pubblicato su la Repubblica il 21 GENNAIO 2024