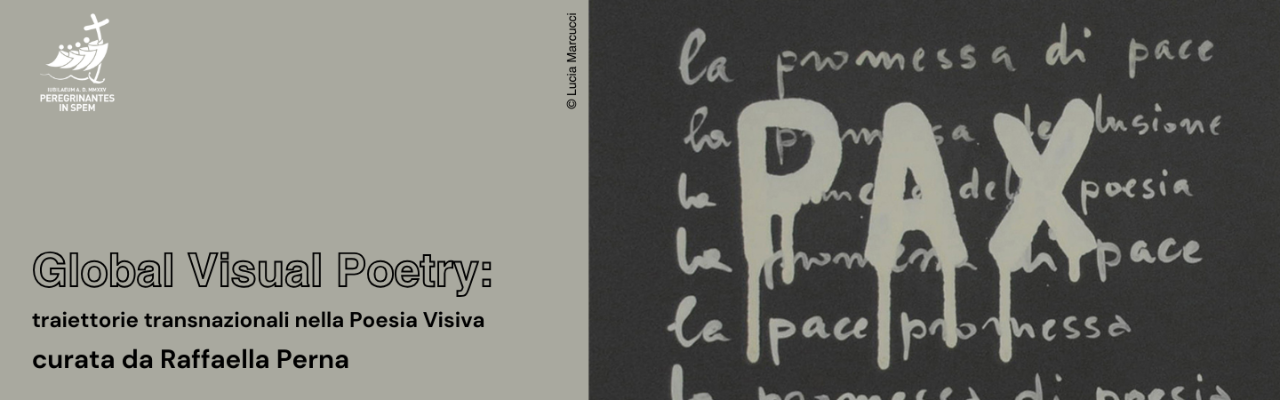Galileo sarebbe stato contento
Sperimentale o teorica: qual è la migliore scienza? I Premi Nobel 2015 per la Fisica, per la Chimica e per la Medicina
di Carlo Maria Polvani
L’attribuzione dei Premi Alfred Nobel scientifici per il 2015 – quelli per la fisica e per la chimica conferiti dalla Reale Accademia Svedese delle Scienze, e quello per la fisiologia o medicina attribuito dal Karolinska Institutet – può essere letta sotto la lente del rapporto fra scienza teorica e scienza sperimentale che ha contrassegnato vari campi scientifici sin dagli inizi del secolo. In fisica nucleare per esempio, molti scientifici ritengono che la via sperimentale sia da prediligere su quella teorica. In medicina o in biochimica, è comune che a ogni scoperta di rilievo si ponga la domanda di un eventuale applicazione nel campo della salute. Questi quesiti sono manifestazioni del delicato equilibrio sul quale si regge il metodo scientifico che cerca di tradurre le osservazioni derivate dal mondo reale con delle teorie capaci di prevedere i fenomeni naturali. Tale equilibrio deve fare i conti con i seguenti interrogativi: il metodo scientifico dipende più dalla logica deduttiva o dall’intuizione astratta? Entro quali limiti i risultati della sperimentazione possono convalidare o inficiare un postulato speculativo e fino a dove la scienza può proporre assiomi prima di sottoporli al vaglio di osservazioni sperimentali? Un elemento che accomuna i laureati del 2015 è che vengono dal ramo applicativo delle loro rispettive scienze e che le loro osservazioni sperimentali hanno indirettamente riaperto la questione dell’equilibrio fra teoria e osservazione in questioni fondamentali dei nei loro rispettivi campi di ricerca.
La valenza sociale dell’attribuzione del premio per la medicina all’irlandese William Campbell, al giapponese Satoshi Omura e alla cinese Touyou Tu per la scoperte di terapie contro i parassiti e contro la malaria è indiscutibile in quanto un essere umano su due è esposto ai rischi delle infermità contro le quali i succitati ricreatori hanno scoperto importanti terapie. Le popolazioni più povere dell’Asia e dell’Africa sono infatti a rischio di contrarre delle forme di malattie parassitarie derivante da vermi che portano ad atroci disabilità dalle orribile conseguenze sociali come la cecità (l’oncocercosi) o il rigonfiamento abnorme di parti del corpo (l’elefantiasi). L’esito positivo degli sforzi di Campbell e di Omura è un tipico caso di quello che Thomas Edison chiamava succes is 10% inspiration and 90% perspiration. Omura ha intuito che gli stessi batteri che producono la streptomicina (l’antibiotico usato per debellare la tubercolosi dal 1943) potevano, se coltivati e selezionati, sinterizzare altre molecole dalle caratteristiche medicinali. Campbell, con un lavoro di biochimica altrettanto minuzioso, è riuscito a isolare da alcuni ceppi batterici di Omura la avertimicina, che impedisce l’operatività del sistema nervoso dei vermi in dose non tossiche per l’organismo infestato da tali parassiti. Anche l’artemisinina (o qinghaosu in cinese) è un prodotto semi-sintetico che deriva da un prodotto naturale: l’erba Artemisia annua di cui la medicina tradizionale cinese fa ampio uso. Benché non vi siano ancora certezze su come il qinghaosuporti all’eliminazione del virus della malaria quando esso si trova ancora nei globuli rossi del corpo dell’ospite, la complessità della sua sintesi conferma l’importanza della conservazione della biodiversità poiché dalle migliaia di specie di animali e di piante che sono oggi a rischio di estinzione sono potenzialmente ricavabili numerosissimi principi bio-medici attivi di cui non si sospetta neppure l’esistenza a tutt’oggi.
Non meno sperimentale ma forse più affascinante nella sua valenza filosofica risulta il lavoro di Takaaki Kajita e Arthur B. McDonald, insigniti dell’onorificenza svedese per la dimostrazione sperimentale dell’oscillazione dei neutrini, particelle subatomiche, cioè dei mattoni basilari che costituiscono l’universo, teorizzate da Wolfgang Pauli (1900-1958) e il cui nome fu coniato da Edorado Amaldi (1908-1989) in una conversazione scherzosa con Enrico Fermi (1901-1954) in Via Panisperna. Le portata delle osservazioni del fisico nucleare giapponese e del suo collega canadese va ricondotta alla pubblicazione nel 2012, da parte del CERN di dati empirici che sostenevano l’esistenza del bosone conosciuto la “particella di Dio”, la cui esistenza era stata postulata da Peter Higgs (1929-) quasi mezzo secolo fa. I neutrino, che esistono dappertutto nell’universo e attraversano la materia a grandi flussi, possono appartenere a tre “sapori”: l’elettronico, il muonico e il tauonico. McDonald e Takkai usando apparecchiature sperimentalei di altissima fatture quale del Super Kamiokande di Tokyo e del Sudbury Neurino Obersavtory in Ontario, hanno dimostrato che essi possono oscillare - come lo aveva sospetato Bruno Pontecorovo (1913-1993) nel 1957 da un sapore all’altro. Questa oscillazione implica che i neutrino abbia una massa e questa scoperta ha una conseguenza teorica notevole perchPé impone una revisione delle previsioni teoriche che per anni si sono date per certe.
Per mezzo dell’identificazione della natura delle particelle si gioca la partita più fondamentale sulla credibilità della “Teoria del Tutto” ossia del tentativo di fare combaciare in un’unica teoria scientifica i risultati della meccanica quantistica, che ebbe come padre Max Planck (1858-1947) e che permise la scoperta del mondo dell’infinitamente piccolo a livello atomico e sub-atomico, e quella della Relatività Generale proposta da Albert Einstein (1879-1955) che evidenziò la leggi fisiche dell’infintamente grande nelle relazione fra spazio e tempo nell’universo. Dalla possibilità o dall’impossibilità di stabilire possibilità di costruire una “Teoria del Tutto” vi sono due concezioni della scienza: una più scettica che postula che l’incompletezza osservata da Kurt Gödel (1906-1978) in matematica si applica alla fisica e che quindi non sia possibile conoscere l’universo con scientifica certezza; e l’altra invece più deterministica che prevede come avrebbero sperato Pierre Simon de Laplace (1749-1827) nel suo Essai philosophique sur les probabilités che sia teoricamente possibile conoscere la natura con assolute certezze.
Il Premio Nobel per la Chimica, infine, è stato assegnato allo svedese Tomas Lindahl, allo statunitense Paul Modrich e al turco Aziz Sancar per aver scoperto i meccanismi di riparazioni della acido desossiribonucleico (ADN o DNA nell’acronimo inglese) a livello cellulare. Le forme di vita sulla terra usano quasi tutte il DNA come codice per conservare l’informazione necessaria al loro sviluppo e replicazione; anche un minimo cambiamento o interpolazione della sequenza del DNA quindi può avere effetti devastanti. Contro la tendenza teoretica comunque, nel 1974, lo svedese Lindahl fu il primo ha sospettare che non era possibile che degli errori non si creassero di continuo nel DNA che come ogni molecola chimica è sottoposta a migliaia di aggressioni per ossidazione, alchilazione, idrolisi da gli agenti più vari raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, variazioni termiche e agenti. chimici vari. Lo scienziato svedese ipotizzava quindi che la conservazione del DNA era possibile solo se le esistevano dei meccanismi di riparazione continuamente all’opera. Qualche anno dopo, Sancar riusciva a identificare un enzima il cui lavoro era proprio quello di riparare il DNA; Hughes poi svelava i meccanismi cellullari che permettono alla sequenza del DNA di difendersi dal più basilare fattore di astrazione ossia il mismatch, la mancate corrispondenza dei gradini che congiungono le due unità che forma la famosa doppia elissi.
Le applicazione mediche di queste scoperte potrebbero risultare essere di enorme portata. Si pensi alla lotta al cancro. Le cellule cancerogene infatti derivano da cellule sane i cui il DNA vien talmente danneggiato da farle impazzari Un potenziamoento dei meccanismi di riparazione cellualre del DNA potrebber pertanto essere di estrea efficaece nel previnoire l’insorgede dit tumoi.
Più genericamente le riparazioni del DNA potrebbero portare a guarire in nuce delle malattie ereditarie, correggendo i geni difettosi (gene editing) ma anche esponendo l’umanità alla tentazione di migliorare i geni attuali e quindi di operare delle modifiche eugenetiche (introdurre nell’uomo dei geni, anche di altri specie, che gli conferirebbero delle possibilità fisiche o mentali superiori). Quello che colpisce di più però è che le mutazioni genetiche con il conseguente insorgere di caratteristiche diverse sono alla base dall’insorgere di nuovi specie. La teoria dell’evoluzione ritiene appunto che le mutazioni genetiche casuali siano il substrato stesso della diversità necessaria per una selezione che porti all’adattamento delle forme di vita. Sarà perciò necessario capire come la teoria dell’evoluzione terrà conto del fatto che alcune mutazioni sono già bloccate dalla natura stessa poiché i meccanismi scoperti da quanti continueranno i lavori dei laureati del 2015 indicheranno che la DNA viene riparata dalle cellule stessi in alcuni casi e in altri no. Anche in questo caso un’osservazione sperimentale avrà un effetto su una teoria scientifica che ha drammaticamente polarizzato i dibati filosofici negli ultimi due secoli.
Forse proprio di questo quindi si tratta: i Nobel di quest’anno hanno fatto giustizia a molti scienziati che, nell’ombra, lavorano su problemi sperimentali la cui portata è solo apparentemente limitata. La scienza incomincia con l’osservazione e con la risoluzioni di problemi pratici. Da questi sforzi, giustamente, si declinano poi le teorie la cui portata filosofica diventa inevitabile, ma che poi devono ritornare la vaglio dell’osservazione. Se no come potrebbe il metodo scientifico fare tenere insieme, le «sensate esperienze» (osservazione sperimentali) e le «certe dimostrazioni» (teorie logiche) come diceva come diceva Galileo Galilei (1564-1642)?
(Da L'Osservatore Romano, edizione quotidiana n. 231, 10/10/2015)