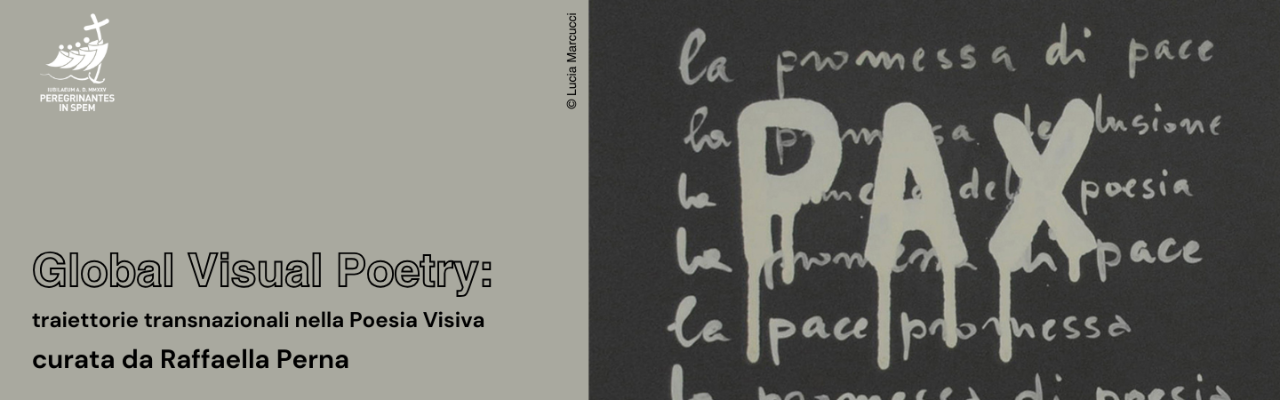Animali evoluti e angeli incarnati
Anniversario dello sbarco sulla luna. Le premesse dell’impresa
di Carlo Maria Polvani
All’apice della Guerra fredda, per stigmatizzare la propaganda sovietica che aveva subdolamente attribuito al primo uomo a compiere un volo in orbita, il 12 aprile 1961, la frase «Non vedo alcun Dio quassù», girava la seguente barzelletta: Jurij Gagarin è convocato da Nikita Chruščëv che gli chiede se abbia trovato Dio nello spazio e risponde: «Sì; ma non lo dirò a nessuno». Poi, incontra il patriarca Alekseij i che gli pone la stessa domanda e replica: «No; ma non lo dirò a nessuno». Fra sé e sé, il cosmonauta conclude — e questa ultima è un’autentica citazione di Gagarin! — «Chi non ha mai incontrato Dio sulla Terra, non lo incontrerà neppure nello spazio».
A quanti ricordano con nostalgia e a quanti non possono ricordare perché troppo giovani, i primi passi sulla luna di Neil Armstrong del 21 luglio 1969, varrebbe la pena includere fra le letture del riposo estivo, il saggio di Marcello Coradini, Viaggiare nello spazio. Non solo scienza ma anche economia e progresso (Bologna, Il Mulino, 2017, pagine 146, euro 11) che offre un’incantevole cronaca del periodo d’oro dell’esplorazione spaziale.
In queste pagine, il già rappresentante della Agenzia spaziale europea presso il Jet Propulsion Laboratory del California Institute of Technology — l’ente che si dedica allo sviluppo delle navicelle robotizzate della Nasa — descrive le tappe essenziali della corsa alla luna: dai successi sovietici guidati dal progettista Sergej Korolëv (1907-1966) — con il lancio del primo satellite artificiale, Sputnik, il 4 ottobre 1957 — fino alla risposta statunitense capitanata dal celebre Wernher von Braun (1912-1977), con la conquista del nostro satellite naturale, per mezzo dei programmi esplorativi Ranger eSurveyor (che, fra il 1961 e il 1968, offrirono una mappatura della superficie lunare migliore di quella del fondo degli oceani) e le missioni Apollo che, fra il 1969 e il 1972, permisero a 12 uomini di camminare sulla luna. Anche lo sviluppo delle stazioni orbitanti è delineato: dalle primigenie Saljut e Skylab (che entrarono in funzione nel 1971 e nel 1973, rispettivamente), alla Mir (che ospitò ben 104 scienziati dal 1986 al 2001) e allo Spacelab (che dovette subire i contraccolpi delle tragedie delle navette Challenger nel 1986 e Columbia nel 2003), fino all’attuale International Space Station (il cui rientro è previsto entro il 2028).
Con la stessa piacevole sinteticità, il docente nell’università di Genova e di Trento traccia il progresso dell’invio di sonde robotizzate verso i pianeti del sistema solare — Venere (la cui atmosfera studiata da Magellan, fra il 1990 e il 1994, potrebbe fornirci preziose informazioni sui cambiamenti climatici sulla Terra); Mercurio (intorno al quale orbitò Messenger fra il 2011 e il 2015, confermando che la superficie del pianeta poco più grande della luna subisce delle escursioni termiche quotidiane di 600 gradi centigradi, dai –170° notturni ai +430° diurni), Marte (che è stato già oggetto di 52 missioni e desta forte interesse per le sue riserve acquifere congelate che potrebbero contenere tracce di vita fossile) e quelli più lontani osservati grazie a sonde come Galileo (che restò dal 1995 al 2003 in orbita su Giove) o Cassini-Huygens (che è entrato ed è ancora in quella di Saturno) — e persino su corpi celesti molto più piccoli fra cui asteroidi e comete — quali la cometa di Halley, il cui nucleo composto di ghiaccio cristallizzato su della polvere spaziale fu verificato da Giotto nel 1986.
In risposta a quanti sono dell’opinione che gli ingenti investimenti pubblici stanziati per finanziare questi encomiabili sforzi scientifici siano stati sproporzionati rispetto alla loro utilità pratica, l’autore menziona alcune delle oltre seimila ricadute tecnologiche dei programmi spaziali fra cui: la tomografia assiale computerizzata o Tac, che, utilizzata per rilevare le micro-imperfezioni nei componenti delle missioni, diventò strumento di diagnostica per immagini; la liofilizzazione che, sviluppata per permettere la conservazione di cibo con la minima perdita di nutrimento, trovò un ruolo di notevole importanza nell’industria farmaceutica; gli impianti di rilevamento incendi che, usati nel più imponente razzo mai costruito, il Saturn v, contribuirono al dimezzamento delle morti per incendio nell’ultimo mezzo secolo.
Forse, la portata di questi contributi spiega perché Coradini manifesti una punta di amarezza quando sostiene che il futuro dell’esplorazione spaziale potrebbe essere compromesso dai troppi interessi politici e commerciali. O forse, questo suo disappunto deriva dal fatto che egli vede nei viaggi spaziali il proseguimento inevitabile delle grandi migrazioni che, iniziatesi 100.000 anni fa, portarono l’homo sapiens fuori dall’Africa e gli permisero di colonizzare, poco a poco, l’Asia, l’Europa, l’Oceania e l’America. Credere che gli spostamenti dell’umanità — dalle trasmigrazioni geografiche dei nostri lontanissimi antenati fino ai recentissimi progetti di colonizzare altri pianeti quali il Mars Direct proposto nel 1996 — abbiano avuto come cause fondamentali non tanto la fame e la necessità, quanto la sete del sapere e il bisogno di esplorare, può sembrare una visione eccessivamente idealista sulla falsa riga del “mito del buon selvaggio”, introdotto da Anthony Shaftesbury (1671-1713) ed elaborato da Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Sarebbe nondimeno fallace non notare che la natura umana ha dovuto da sempre cimentarsi con le spinte derivanti dagli istinti di sopravvivenza da un lato e da ideali trascendenti dall’altro.
Questa contrapposizione si manifesta metaforicamente in alcuni dati paradossali dell’esplorazione spaziale. Un pendolare che percorre 40.000 chilometri all’anno con la sua utilitaria, completa la distanza fino alla luna (400.000 chilometri circa) ogni dieci anni. Ma un homo sapiens di 100.000 anni fa, che avesse potuto imbarcarsi su una navicella spaziale moderna (procedente alla velocità tipica di 40.000 chilometri orari) verso Proxima Centauri (la stella più vicina alla Terra che dista 40 mila miliardi di chilometri) sarebbe quasi in procinto di giungere a destinazione. Questo contrasto è altresì incarnato dai tre pionieri che, insieme a Robert Esnault-Pelterie (1881-1957), scoprirono i principi teorici della missilistica: Konstantin Tsiolkovskij (1857-1935), Robert Goddard (1882-1945) e Hermann Oberth (1894-1989).
Al primo, che aveva perso l’udito cadendo in acque ghiacciate da piccolo, non fu permesso frequentare la scuola d’obbligo; visse la maggior parte della sua vita recluso in una casa di legno a Kaluga, a 200 chilometri da Mosca, scoprendo, nel 1896, le equazioni per sfuggire all’attrazione terrestre e coniando la frase oggi ripresa sullo stemma del capoluogo dell’omonima Oblast’: «La Terra è la culla dell’umanità, ma non si può vivere per sempre in una culla».
Il secondo, quando i fratelli Wilburn e Orville Wright riuscivano appena a fare volare il biplano Flyer su distanze di poche decine di metri, ebbe la fortuna di ricevere un finanziamento dalla Smithsonian Institution; quando, nel 1919, pubblicò il suo trattato A method for reaching extreme altitudes (“Un metodo per raggiungere altitudini estreme”) fu ridicolizzato dalla comunità scientifica che lo ritenne un sognatore inguaribile.
Il terzo, che da ragazzo aveva quasi imparato a memoria De la terre à la lune di Jules Verne, scrisse quello che oggi è considerato il contributo più fondamentale della missilistica Wege zur Raumschiffahrt (“La via per i viaggi spaziali”), ma intrattenne rapporti alquanto conflittuali con il mondo accademico, che non gli aveva permesso di fregiarsi del titolo di dottore rifiutando la sua tesi di laurea.
Tre visionari ai quali si addicono i versi della poesia Uomini dell’autore siberiano appena scomparso, Evgenij Evtušenko (1933-2017), che divenne famoso proprio durante l’ottepel’ (“disgelo”) che caratterizzò il periodo della de-stalinizzazione: «Non esistono uomini non interessanti / i loro destini sono come le cronache dei pianeti / […] È la legge di un gioco spietato. / Non sono uomini che muoiono, ma mondi».
La complessità del comportamento umano, a volte, si può spiegare ammettendo che l’uomo sia un animale evoluto ma comunque guidato da inclinazioni primarie, e a volte, si può comprendere solo concependo l’uomo come depositario di uno spirito indomabile intrappolato in un corpo mortale: «Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, cos’è l’uomo perché te ne ricordi e il figlio dell’uomo perché te ne curi? Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli» (Salmi 8, 3-6).
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLVII, 2017, N.165 p.4)