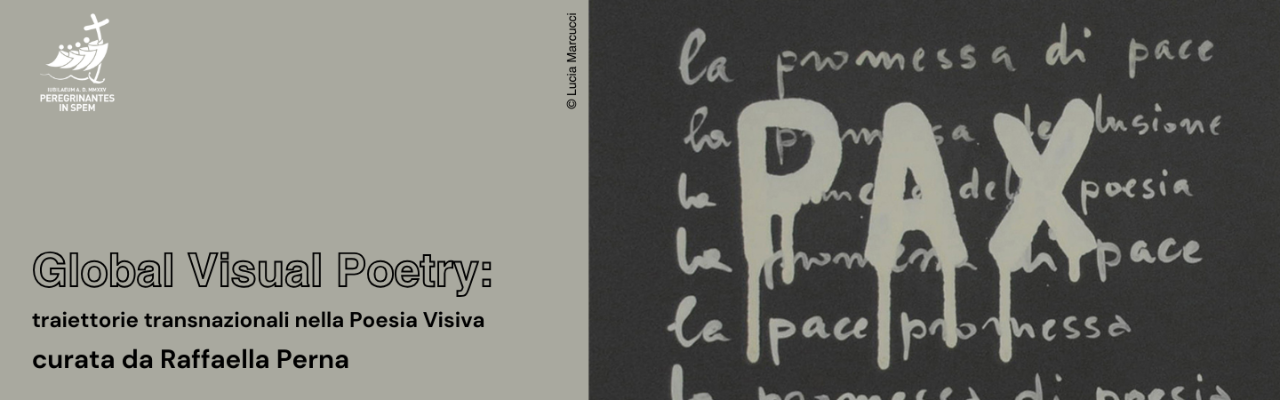L’eleganza del polpo
Piovre ed esseri umani a confronto
di Carlo Maria Polvani
Ai campionati mondiali di calcio svoltisi in Sud Africa nel 2010, la nazionale tedesca disputò sette partite, vincendone cinque e perdendone due. Prima di ogni incontro, furono presentate a una piovra del parco acquatico di Oberhausen due gabbiette piene di cibo; su una era affisso il tricolore tedesco e sull’altra la bandiera della squadra avversaria. Scegliendo da quale stia nutrirsi, il cefalopode predisse correttamente l’esito di tutti gli incontri della Mannschaft e indovinò persino l’affermazione della Furia Roja nella finale del torneo.
Il palmarès divinatorio della piovra renana, che aveva una sola probabilità su 256 (28) di avverarsi, attesterebbe della notevole intelligenza dei polpi — da non confondersi con i polipi (le anemoni di mare), che appartengono invece alla famiglia delle meduse — appena celebrata nell’ultimo libro della nuova collana «Animalia» dell’Adelphi, Altre menti(Milano, 2018, pagine 303, euro 22). Per capire l’argomentazione sostenuta da Peter Godfrey-Smith in tale opera, si ponderino alcuni dati sulla sequenza temporale dell’apparizione delle specie animali sulla Terra. Il nostro pianeta si formò all’incirca 4,5 miliardi di anni fa; organismi monocellulari simili a dei protozoi riuscirono a evolversi in animali pluricellulari primitivi, più o meno 650 milioni di anni or sono. Queste creature subirono una rapidissima diversificazione nel breve periodo fra i 550 e 500 milioni di anni fa: i primi rami a separarsi furono quelli dei poriferi (le spugne) e quelli dei cnidari (le meduse), con il tronco restante che si spezzò a sua volta in vertebrati e in invertebrati. Anche questi ultimi si divisero ben presto: prima sorsero gli anellidi (i vermi), poi i molluschi (di cui fanno parte i cefalopodi) e infine, gli artropodi (i crostacei e gli insetti). Passato questo corto periodo chiamato esplosione cambriana, la differenziazione delle specie rallentò vistosamente e i vertebrati si suddivisero gradualmente in pesci (450 milioni di anni fa), in anfibi (350 milioni di anni fa), in rettili (300 milioni di anni fa), in uccelli (200 milioni di anni fa) e infine, in mammiferi (150 milioni di anni fa), le cui specie incominciarono a dominare le altre solo dopo l’improvvisa estinzione dei dinosauri, avvenuta 60 milioni di anni or sono.
Partendo dal fatto che la linea evolutiva dei mammiferi, collegata a quella dei vertebrati, si sarebbe distaccata da quella dei cefalopodi, collegata a quella dei molluschi, da almeno mezzo miliardo di anni e che i trasferimenti genici orizzontali (il passaggio di materiale genetico fra individui che non siano discendenti) siano eventi rarissimi negli animali (anche se frequenti fra i batteri), il docente di filosofia della scienza alla City University of New York, postulando che gli octopus vulgaris e gli homo sapiens siano il risultato di processi evolutivi indipendenti, ritiene che una comparazione tra le due specie costituisca un intrigante caso di studio dei meccanismi dell’evoluzione. Un confronto tra le capacità intellettive delle piovre e degli esseri umani risulta difatti molto interessante, dato che il quoziente di encefalizzazione (una misura biometrica basata sul rapporto fra massa corporea e massa encefalica) e il sistema cerebrale dei cefalopodi sono di gran lunga superiori a quelli degli altri invertebrati (per esempio un gatto possiede 700 milioni di neuroni, un polpo poco più di 500 milioni e un’aragosta appena 200.000).
D’altronde, le ricerche sul comportamento delle piovre confermano le loro eccezionali qualità di scaltri cacciatori dotati di un ottimo senso dell’orientamento e capaci di manipolare oggetti con finalità specifiche. Ad esempio anche se non godono di stereognosia — il saper identificare gli oggetti con il tatto — sono state osservate piovre che si rivestivano minuziosamente con pezzi di gusci di noci di cocco per tendere imboscate a ignare prede.
Dal punto di vista evoluzionistico, appare normale che i polpi si siano adattati al loro ambiente — ad esempio, per evitare un abnorme contenuto di ossigeno nel sangue, al posto dell’emoglobina usano la emocianina che rende il colore del loro sangue blu — ma è disorientante notare che la loro competitività adattativa sia dovuta a un sapiente dosaggio di soluzioni a volte innovative e a volte riscontrabili in altre specie.
Ne è un ottimo esempio la decentralizzazione del sistema nervoso, che vede i tre quinti dei neuroni delle piovre collocarsi nei tentacoli. Questa peculiarità è verosimilmente dovuta al fatto che non avendo articolazioni, le braccia dei cefalopodi — che in realtà, non sono né braccia, né gambe, la parola significa “testa-piedi”, ma delle labbra che, anche dopo l’amputazione, continuano a muoversi autonomamente — devono potere eseguire dei movimenti complessi e veicolare delle esperienze sensoriali avanzate. Un’altra squisita illustrazione di quanto atipiche siano le piovre, si riscontra nelle loro stupefacenti capacità di vedere senza essere viste. Grazie a tre diversi tipi di cellule nella loro pelle che, rispettivamente, assorbono (i cromatofori ), deviano (gli iridofori) e riflettono (i leucofori) la luce, possono realizzare dei mimetismi perfetti che, in frazioni di secondo, le rendono invisibili. Contrariamente agli insetti che hanno sviluppato degli occhi composti — formati da migliaia di strutture recettive microscopiche, le ommatidi, che modellano un’immagine d’insieme a mosaico — i cefalopodi possiedono degli occhi simili a quelli dei mammiferi sul modello di fotocamera.
Una lente flessibile (il cristallino) permette alla luce di imprimere un’immagine a fuoco su uno sfondo fotosensibile (la retina). Si postula che questa scelta sia stata causata dall’esigenza di una visione più precisa a scapito di una minore percezione della velocità dei movimenti; gli insetti, specialmente quelli che volano come le mosche o le libellule vedono, infatti, sfocato; ma il gran numero di ommatidi a loro disposizione, gli assicura un rilevamento del movimento almeno cinque volte più rapido del nostro.
Per spiegare queste e altre singolarità dei cefalopodi, vengono invocate tesi come quella della evoluzione parallela — specie diverse avrebbe ereditato dei geni latenti che si sarebbero espressi molto tempo dopo la loro biforcazione evolutiva — o quella della evoluzione convergente (la pressione selettiva sarebbe stata così incisiva da imporre soluzioni adattative molto simili a specie molto diverse).
Al di là della validità di queste ipotesi, l’apprezzabile acume dei polpi non può non fare sorgere dei quesiti circa la natura stessa dell’intelligenza. I polpi possiedono delle facoltà cognitive avanzate quali la memoria procedurale (il ricordare la metodologia da seguire nella risoluzione di un problema specifico) e forse anche la memoria episodica (il rammentare l’esperienza soggettiva collegata a un avvenimento specifico e non semplicemente l’avvenimento stesso) da alcuni ritenuta una forma primigenia di conoscenza di se stessi. Tuttavia, le piovre hanno poche relazioni sociali costruttive (la comunicazione fra loro viene usata per lo più per minacciare ritorsioni in caso di violazioni territoriali), non si prendono cura della loro prole (alla meglio, fanno la guardia alle uova per poi abbandonarle appena dischiuse) e non tramandano efficacemente il loro sapere ai loro simili (nei loro tre anni di vita, costituiscono da sole il loro patrimonio conoscitivo che viene, in gran parte, disperso alla loro morte).
Il loro comportamento sembra quindi dare ragione a Howard Gardner, padre della teoria delle intelligenze multiple. Secondo il cattedratico di Harvard, l’intelligenza umana si declinerebbe in dieci tipi di potenziali bio-psicologici: il linguistico, il logico-matematico, lo spaziale, il corporeo-cinestetico, il musicale, l’interpersonale, l’intrapersonale, il naturalistico, l’esistenziale e il morale. Seguendo queste categorie, la mappatura dell’intelletto dei cefalopodi risulterebbe sensibilmente diversa dalla nostra. Questo spiegherebbe perché i cefalopodi, nel nostro subconscio culturale collettivo, ricoprono spesso il ruolo di alieni, al contempo terrificanti e affascinanti.
Perfino Linneo (1707-1778) non escludeva che nei fondali dei fiordi scandinavi abitassero i Kraken, dei mostri simili alla piovra gigante di Ventimila leghe sotto i mari. Accogliendo il professore Artax a bordo del sottomarino Nautilus — nome che non potrebbe essere più appropriato visto che il nautilo è un mollusco che vive a grandi profondità — il capitano Nemo lo avvertì che non sarebbe potuto ritornare a casa, per evitare che si venisse a sapere dell’esistenza di un genio eccentrico che aveva rinunciato alla società umana per dedicarsi all’esplorazione dell’universo sottomarino. Volendo garantire un lieto fino al suo romanzo, Jules Verne si vide perciò obbligato a rispedire il misantropo negli abissi, facendolo inghiottire guarda caso, da un maelstrom, il mulinello marino tipico delle coste norvegesi.
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLVIII, 2018, N.272 p.5)