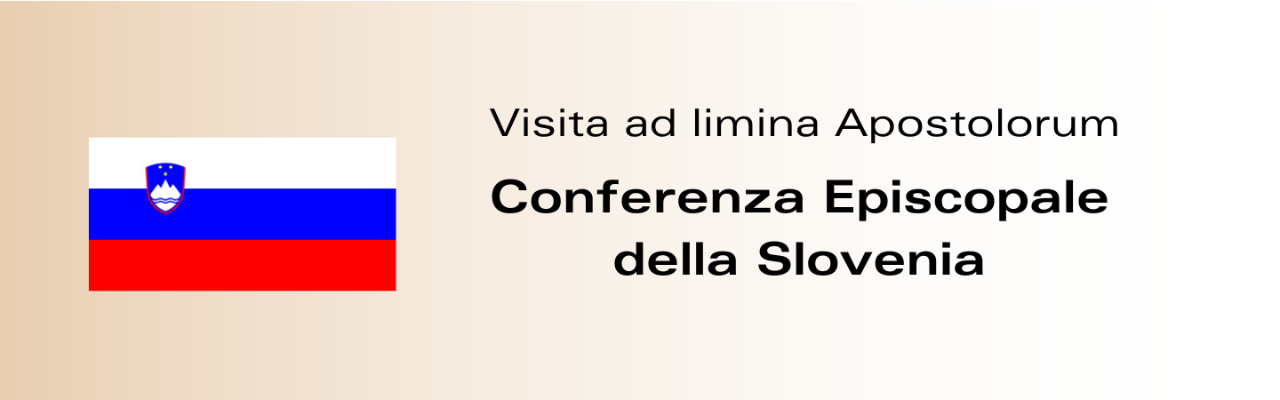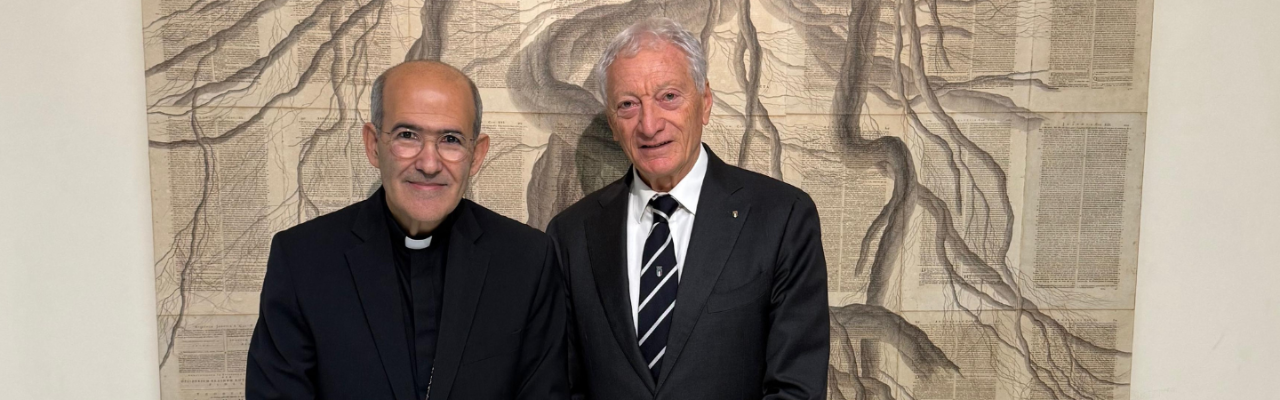Annunciare il Vangelo in contesto universitario
A Roma un convegno per rafforzare la pastorale delle cappellanie universitarie
Pubblichiamo stralci delle relazioni del Prefetto del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, il cardinale José Tolentino de Mendonça, e di padre Antonio Spadaro, sottosegretario del medesimo Dicastero, pronunciate in occasione del convegno Verso una visione poliedrica. Rafforzare le cappellanie universitarie per la crescita spirituale, l’impegno culturale e la creazione di comunità in corso a Roma (dal 23 al 24 novembre) presso la Curia dei gesuiti in Borgo Santo Spirito. Un incontro dei responsabili della pastorale universitaria e dei cappellani degli atenei cattolici — si legge nella presentazione della due giorni — che vuol essere un momento di riflessione, ma anche un tempo di condivisione di “buone pratiche” al servizio della missione, secondo le modalità proprie del mondo universitario, attraverso l’insegnamento e l’impatto nella società. Il convegno si concluderà con la Santa Messa nella basilica di San Pietro, venerdì mattina, seguita dall’udienza con Papa Francesco.
«Verso una visione poliedrica»: così abbiamo voluto chiamare il primo incontro di Pastorale Universitaria organizzato dal Dicastero, di recente creazione, per la Cultura e l’Educazione. E senza nasconderci che il titolo rende conto di una pretesa: quella di contribuire non solo a una riflessione allargata, ma anche a un creativo e sinodale potenziamento della missione in questo ambito che ci accomuna tutti. In verità, la pastorale universitaria non può rimanere indifferente a quel dinamismo che la sintesi finale della sessione del Sinodo tenutasi lo scorso mese di ottobre designava come una «nuova consapevolezza della dimensione sinodale della Chiesa», né alla proclamazione che «piuttosto che dire che la Chiesa ha una missione» si deve riconoscere «che la Chiesa è missione». Al contempo, è il Sinodo stesso a ricordarci che, quando ci confrontiamo con la chiamata alla missione, dobbiamo partire altresì dalla constatazione che «i contesti culturali in cui la Chiesa è presente rivelano bisogni spirituali e materiali differenti». Di quali bisogni spirituali si tratta? E quali materiali differenti apportano le università alla costruzione dell’odierna missione ecclesiale? E come ci rendiamo noi più o meno coscienti di tale diversità? L’ambiente universitario è certamente un contesto culturale specifico, con sfide proprie, e abbiamo bisogno di ascoltare insieme, di nuovo, i suoi bisogni e aspirazioni, e di sentire che cosa lo Spirito dice a questa porzione di Chiesa (Ap 2,7).
«Tu che cosa vedi?»
Nell’esperienza della fede biblica ci rendiamo conto che la visione è una tappa importante nel processo di rivelazione della Parola di Dio e della risposta a tale Parola attraverso la profonda adesione del Popolo di Dio. Ciò accadde tanto nell’Antico Testamento, con i profeti, come nel Nuovo Testamento, in particolare nell’azione di Gesù. La visione ha un ruolo propulsivo, mette in discussione lo stato attuale delle cose, smuove il nostro comodismo da arrivati, fa emergere altre possibilità, fa da leva al presente rilanciandolo. Ed è curioso che talune di queste visioni non siano sogni o immagini oniriche da mettere sul piano di un’ermeneutica del fantastico. Dio parla anche attraverso la storia minuta e i suoi eventi ordinari. C’è un’operazione che potremmo chiamare narrativizzazione della Rivelazione. Dio comunica attraverso la realtà storica, le sue contraddizioni e i suoi sogni, manifestandosi negli interrogativi, nelle impasse, nei passaggi e nelle trasformazioni. È così che il profeta Geremia udì il comando rivoltogli dal Signore che diceva: «Alzati e scendi nella bottega del vasaio; là ti farò udire la mia parola» (Ger 18,2). Entrò e semplicemente vide: «Se si guastava il vaso che stava modellando, come capita con la creta in mano al vasaio, [questi] riprovava di nuovo e ne faceva un altro» (Ger 18,4). La visione descrive così tre tappe, note a tutti: la creta che si guasta tra le mani del vasaio; il coraggio di ricominciare da capo; la saggezza di fare con essa un altro vaso.
Allo stesso modo, c’è un passaggio del Vangelo di Marco (Mc 8,22-26) che ci permette di vedere con chiarezza all’opera la pedagogia di Gesù sullo sguardo. «Giunsero a Betsaida, e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e, dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: “Vedi qualcosa?”. Quello, alzando gli occhi, disse: “Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano”. Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente, fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa».
Gesù prende l’uomo per mano e lo conduce fuori dal villaggio. La trasformazione avviene quando accettiamo di spostarci dal nostro punto di vista abituale (dal nostro villaggio, potremmo dire) verso un luogo nuovo, che non è tanto un luogo quanto, piuttosto, una relazione, una visione nuova. Quando si trovano soli, Gesù mette della saliva sugli occhi del cieco. È un elemento simbolicamente forte, perché la saliva è una linfa, una secrezione che viene da Gesù stesso. Egli non prepara una medicina esteriore, non propone come rimedio una pianta o le viscere di un pesce. La medicina è Gesù. Ed è allora che nasce il più imprevedibile dei dialoghi. Gesù chiede all’uomo: «Tu che cosa vedi?»; è una domanda puntuale, non generale né astratta. «Tu che cosa vedi in questo momento?». «Vedo gli uomini e li vedo come alberi che camminano». Non c’è nessuna lamentela, nessuna accusa, ma il coraggio dell’obiettività: «Io vedo questo». Gesù allora può correggere, riorientare il suo sguardo, e l’uomo comincia a vedere nitidamente. L’autenticità di quell’uomo, che ammette «non ci vedo bene», «vedo gli uomini come alberi», gli offre l’opportunità di essere guarito e di arrivare a vedere con chiarezza. Abbiamo bisogno di imparare la semplice accettazione della storia per quello che è. Di accettare la vita senza moralizzare, senza occultare, esponendo la nostra situazione, nella fiducia che Egli ci può trasformare. È in questo modo che Gesù gli permette di abitare un orizzonte nuovo, una nuova visione: abitare la verità come fosse una soglia.
«Tu che cosa vedi?» e «Che cosa vedi in questo momento?» sono punti di partenza preziosi anche per la nostra riflessione. Ma nel vedere c’è una dimensione drammatica, che ci costringe a rivedere criticamente i nostri limiti. Come ricorda Gesù stesso, noi possiamo ascoltare senza capire e guardare senza vedere per davvero (Mt 13,14). Credo che sia di questo che papa Francesco parla quando ci sfida a sostituire la sfera con il poliedro. Lo fa, per esempio, nella sua Esortazione Apostolica programmatica Evangelii gaudium e successivamente nella Costituzione Apostolica Veritatis gaudium. Dice: «Il modello non è la sfera... Il modello è il poliedro, che riflette la confluenza di tutte le parzialità che in esso mantengono la loro originalità... e che veramente incorpora tutti» (EG 236). La sfera e il poliedro sono due modelli di visione. La contrapposizione che il Santo Padre propone non intende mettere in competizione tra loro delle figure geometriche, ma aiutarci a pensare dei modelli di lettura della realtà, dei paradigmi di organizzazione pastorale. La sfera descrive un ambiente in termini totali: contiene tutte le cose e nulla esiste al di fuori di essa. Per questo parliamo di sfera terrestre, di atmosfera o, nelle culture digitali, di blogosfera. Questa ambizione di comprendere la realtà in modo olistico può essere rassicurante, d’altro lato corre però il rischio di costituire un’illusione, poiché la comunità universitaria possiede, è vero, aspetti fondamentali comuni – non è un caso che nella parola “università” ben risalti “uni—”, da uno, unico, universale –, ma è intrinsecamente costituita da una vasta diversità con la quale siamo chiamati a confrontarci, anche dal punto di vista pastorale. Diversità umana, diversità di saperi, di percorsi, di identità o di ruoli. L’università non è un tutto omogeneo e continuo. Per questo l’immagine del poliedro può venirci in aiuto. La sua etimologia si basa sull’associazione tra due componenti lessicali e semantiche, dove poli— sta per “vari, diversi, molti” e hedra— significa “facce”. Il poliedro è dunque una figura che, in direzione contraria alla pratica del punto di vista esclusivo o del pensiero unico, richiama la nostra attenzione sugli aspetti diversificati e sulle molteplici dimensioni che entrano nella composizione della realtà, sull’architettura complessa delle relazioni sociali e personali. La realtà non si presenta sotto una sola forma: non è piana e rigida, è multiforme e plastica; non si presenta come uno schema che si ripete automaticamente, bensì come una versatilità sempre capace di sorprendere. La pastorale universitaria deve tenere conto di questo dato di fatto. (...)
Osare la creatività e il rinnovamento
Nella Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae, papa san Giovanni Paolo IIoffriva alle Università Cattoliche una spinta di incoraggiamento su cui vale la pena ritornare. Essa è del resto nella linea di quanto era stato affermato dal concilio Vaticano II , poiché la Gravissimum educationis aveva già assegnato alle scuole superiori legate alla Chiesa l’orizzonte di indagare «accuratamente le nuove questioni e ricerche suscitate dai progressi dell’epoca moderna», dimodoché «si colga più chiaramente come fede e ragione si incontrano nell’unica verità» (GE 10). Lo spirito della Costituzione Apostolica Ex corde Ecclesiae è certamente quello di radicare le Università Cattoliche nel «cuore della Chiesa» (n. 1) e della sua missione, in una «ardente ricerca della verità» (n. 2), nella «fedeltà al messaggio cristiano» (n. 13) e nell’«impegno istituzionale al servizio del popolo di Dio e della famiglia umana» (n. 13). Ma sfida altresì l’università a porsi come «un centro incomparabile di creatività» (n. 1), a sentirsi chiamata «ad un continuo rinnovamento» (n. 7), specialmente «nel mondo di oggi, caratterizzato da sviluppi tanto rapidi nella scienza e nella tecnologia» (n. 7). Il rinnovamento costante, in un’istituzione che fa della ricerca della verità e della sua trasmissione disinteressata il proprio modo di esistenza, deve essere perciò considerato una cosa normale. Le Università Cattoliche devono in effetti dialogare con il nuovo, lavorare a fondo le domande e le problematiche attuali, e costituirsi esse stesse come grandi laboratori del futuro. Dalle Università Cattoliche e dalla pastorale in esse vissuta non ci si aspetta solamente che mantengano viva la nobile memoria del passato, ma che siano anche sensori, e incubatrici, del domani. Questo rinnovamento che le caratterizza deve essere comunque accompagnato e sostenuto, come ricorda la Ex corde Ecclesiae, dalla «chiara consapevolezza» (n. 7) di quella che è la sua natura e identità.
Non c’è il minimo dubbio che il futuro solleciti una visione interattiva, una maturazione poliedrica della realtà e l’audacia di rischiare. Il rischio è, lo sappiamo bene, indissociabile da un contesto educativo degno di questo nome. Lo ricorda con passione papa Francesco: «Un educatore che non sa rischiare non serve per educare. (…) Tu sei sicuro in questo punto, ma questo non è definitivo. Devi fare un altro passo. Forse scivoli, ma ti alzi, e avanti… Il vero educatore dev’essere un maestro di rischio».
Le università, e a maggior ragione le università della Chiesa, si trovano a un crocevia di possibilità culturali, scientifiche, sociali e religiose. Non vivono per sé stesse, come fossero impermeabili bolle di realtà. Al contrario, tanto più si sviluppano quanto più si fanno capaci di ascolto, di esercizio corresponsabile di pratiche collaborative, di incontro generativo tra persone e culture. A tale scopo, è necessaria un’intelligenza creativa, ma anche un discernimento che non può essere parziale né improvvisato, ma radicato nei propri valori. All’inizio del suo pontificato, sottolineando il ruolo decisivo delle università nelle dinamiche della transizione culturale che stiamo vivendo, papa Francesco esortava: «È importante leggere la realtà guardandola in faccia. Le letture ideologiche o parziali non servono, alimentano solamente l’illusione e la disillusione. Leggere la realtà, ma anche vivere questa realtà, senza paure, senza fughe e senza catastrofismi. Ogni crisi, anche quella attuale, è un passaggio, il travaglio di un parto che comporta fatica, difficoltà, sofferenza, ma che porta in sé l’orizzonte della vita, di un rinnovamento, porta la forza della speranza. E questa non è una crisi di “cambio”: è una crisi di “cambio di epoca”. È un’epoca, quella che cambia. Non sono cambiamenti epocali superficiali... L’Università come luogo di “sapienza” ha una funzione molto importante nel formare al discernimento per alimentare la speranza». Questo si richiede alla Pastorale Universitaria: che alimenti la speranza. Che sia una antenna e una sonda per diffondere la novità dello Spirito del Risorto.
di JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA