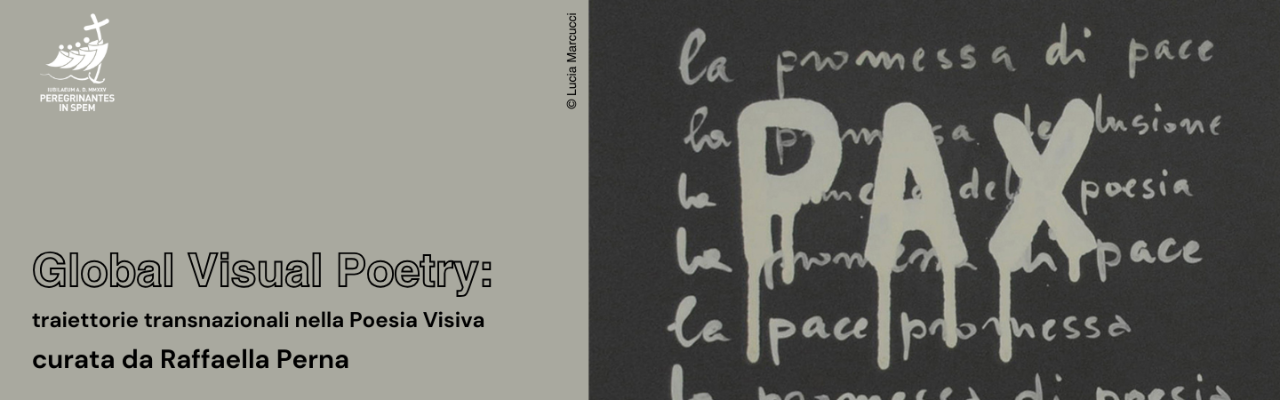Darwin, la Genesi e il mistero del male
Fede e scienza in dialogo alla luce delle nuove scoperte della genetica
di Carlo Maria Polvani
Per descrivere l’essenza filologica dei primi capitoli del libro della Genesi, il Card. Gianfranco Ravasi ha coniato il termine: “eziologia metastorica sapienziale”. Tale sintetica espressione d’ispirazione rahneriana racchiude tre elementi; questi testi biblici, infatti, costituiscono un’antichissima riflessione teologico-filosofica (da qui, la connotazione di “sapienziale”) su dei caratteri strutturali immersi nella storia (da qui, l’aggettivo “metastorico” inteso come descrittivo della portata degli eventi ma non garante dei loro dettagli fattuali) che ne palesano le cause elementari (da qui, il sostantivo “eziologia”, l’analisi delle cause dei fenomeni). Tale squisita complessità spiega in parte perché, sin dalla pubblicazione della teoria darwinista sull’origine delle specie, queste stesse pagine bibliche sono state al centro di acerrimi dibattiti fra scienziati e teologi, precipuamente intorno all’origine delle forme di vita sul nostro pianeta e alla peculiarità dell’uomo rispetto alle altre specie animali.
Conscio delle infelici incomprensioni che si sono verificate, il giovane ricercatore Luca Di Gioia ha portato avanti, sotto la direzione del Prof. Louis Caruna della Pontifica Università Gregoriana, la sua ricerca dottorale dal titolo “Evil, theodicy and evolutionary theory: old arguments facing new data” (Gregorian & Biblical Press, 2020). A rendere ancora più complesso il tema con il quale si è cimentato, il fatto che la questione della teodicea – ossia lo studio teologico-filosofico volto a giustificare la realtà della sofferenza e del male, sostenendo al contempo l’esistenza di un Dio buono e onnipotente – ha tormentato per secoli, sia il pensiero ebraico (come lo dimostra il libro di Giobbe) sia il pensiero classico (come riscontrato nei trattati di Epicuro), producendo risposte divergenti e a volte, incompatibili fra loro.
La metodologia usata da Di Gioia è tanto ineccepibile quanto elegante. Egli riprende le dottrine teologiche classiche intorno al problema del male riconducibili a tre giganti del pensiero cristiano. La prima, proposta da Sant’Ireneo e conosciuta come “argomento pedagogico”, inquadra il male all’interno di un piano salvifico divino volto al bene del creato e dell’umanità. La seconda, molto conosciuta poiché introdotta da Sant’Agostino, è quella della privatio boni che concepisce il male come mera privazione del bene. La terza è una rivisitazione dell’anteriore, condotta da San Tommaso in chiave aristotelica, nella quale si sviluppano le posizioni agostiniane all’interno di una più articolata e più dinamica visione della natura.
Avendo disposto questi tre pilastri, il Docente alla Gregoriana non esita a formulare con chiarezza le tre sfide che il darwinismo classico rappresenta verso queste dottrine che, per semplicità si potrebbero riassumere così: le cause del male, della sofferenza e dalla morte sono individuabili senza invocare colpe morali dell’uomo e senza interrogarsi sul ruolo di Dio, poiché esse sono unicamente elementi costitutivi del meccanismo naturale dell’evoluzione di organismi autoreplicanti, che si snoda dalla cieca causalità della comparsa di diversità genetiche fino alla loro brutale selezione, così favorendo la sopravvivenza degli organismi più adattati al loro ambiente.
Davanti a queste sfide, il Prof. Di gioia avrebbe potuto ricorrere alla nota soluzione proposta da Stephen Jay Gould conosciuta con l’acronimo “Noma” da “non-overlapping magisteria”. Secondo la Noma, la scienza e la religione hanno diverse aree d’indagine; la prima spiega i fatti osservabili e la seconda espone valori esistenziali; quindi, esse propongono soluzioni non sovrapponibili e inerenti esclusivamente alle loro rispettive sfere di competenza. Il ricercatore ha voluto invece mettere in dialogo i dati scientifici con quelli teologici, per analizzare come le due fonti di sapere potessero arricchirsi dialogicamente l’una con l’altra.
La sua ipotesi di fondo essendo che, quando la teoria dell’evoluzione è valorizzata da dati a Charles Darwin sconosciuti – per lo più derivanti dalla genetica moderna e dall’epigenetica, dalla biometria della composizione genetica delle popolazioni e dalle recenti scoperte della paleontologia e dalla paleogenetica, come avviene nella cosiddetta “Modern Theory of Evolution” – e quando le riflessioni cristiane sul male sono valutate in un senso analogico – ossia, nella consapevolezza e rispetto del limite della comprensione umana del mistero di Dio – esistono ampie zone di collaborazione fra la scienza e la fede, nell’elaborazione di una più completa e articolata visione sia della natura e delle sue finalità, sia dell’uomo e della sua condotta.
Il merito del lavoro del Prof. Di Goia – al di là degli ulteriori esami che ne confermeranno e infirmeranno la validità per quanto riguarda la possibile convergenza o divergenza fra il darwinismo moderno e le teorie cristiane classiche sul male – è quello di aver intrapreso con successo un modo di procedere nella ricerca che, lungi da rimanere intrappolata in polemiche spesso retaggio di incomunicabilità passate, lavora senza timore, tenendo conto di tutti i dati disponibili oggi. Le conoscenze derivanti da diverse fonti del sapere, soprattutto quando non sono facilmente armonizzabili le une con le altre, non andrebbero pertanto ingabbiate in categorie ermetiche che rischiano il prodursi di sovrapposizioni forzate, ma invece analizzate onestamente alla ricerca di un’autentica convergenza che arrisica le discipline stesse dalle quali provengono.
Il lavoro di Di Gioia costituisce quindi una lodevole applicazione dello sforzo ardentemente auspicato da Papa Francesco in favore di una ricerca interdisciplinare sull’essenza poliedrica della verità, accessibile quando nella «confluenza di tutte le parzialità, esse mantengono le loro originalità», per corrispondere a un «tutto [che] è più delle parti, ed è anche più della loro semplice somma» (Fratelli tutti, 145; Evangelii gaudium 235, 236).
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLXIII, 2023, N.108 p. 7)