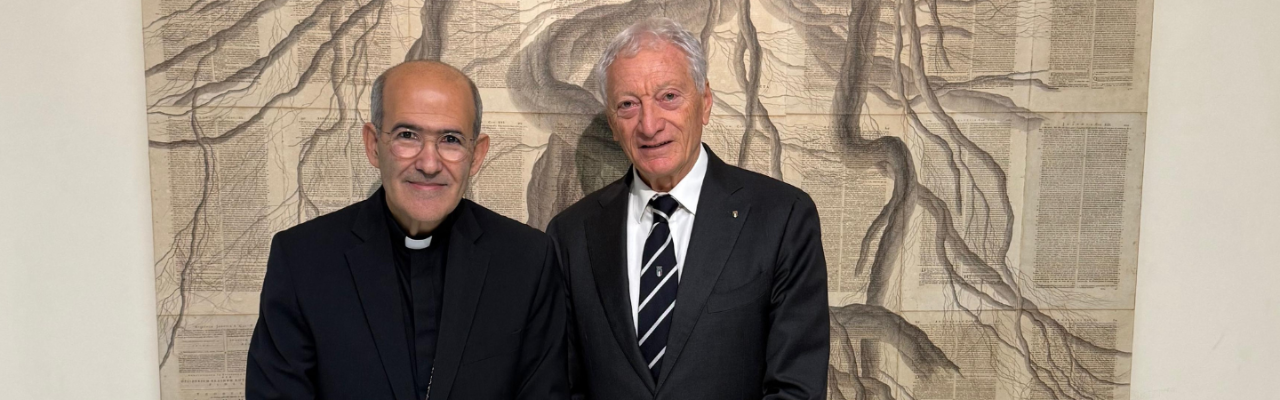La storia di due donne
Crspr, un passo epocale per l’umanità
di Carlo Maria Polvani
La scoperta della struttura del DNA (acido desossiribonucleico) fu possibile grazie al contributo di una ricercatrice di cui pochi ricordano il nome: Rosalind Franklin; fu lei, infatti, usando la cristallografia a raggi X, a ottenere, nel 1952, la prima immagine della famosa doppia elica. La storia fu particolarmente crudele verso questa chimica a cui i colleghi, per pura gelosia maschilista, avevano affibbiato il nomignolo denigratorio di “Terrible Rosy”; dieci anni dopo i suoi rilevamenti, James Watson e Francis Crick dell’Università di Cambridge insieme a Maurice Wilkins (collega di Franklin al King’s College di Londra, che all’insaputa di Rosalind aveva segretamente condiviso i suoi risultati con gli altri due scienziati), ricevettero il premio Nobel, mentre lei era già morta, a 37 anni, di un cancro alle ovaie, probabilmente causato dell’esposizione alle radiazioni di laboratorio (per chi volesse saperne di più su questa commovente storia, si consiglia vivamente di Giulia Galeotti, “In cerca del Padre”, Laterza, 2009). In vero, le scienze in generale e la chimica in particolare, non furono mai generose con le donne. Se si escludono Marie Skłodowska-Curie e la sua primogenita Irène Juliot-Curie, in 120 anni, solo tre donne ricevettero l’agognato riconoscimento per la chimica. Nel 2020, però, per la prima e l’unica volta nella storia, un Nobel fu diviso fra due donne: la francese Emanuelle Charpentier e la statunitense Jennifer Doudna, tutte e due, dal 2021, membri della Pontificia Accademie delle Scienze. A rendere ancora più speciale questo evento, la giustificazione del riconoscimento nelle parole del Comitato Nobel: «per lo sviluppo di un metodo per la modifica del genoma», ossia in ultima istanza, del DNA.
Questo quadro giustifica l’interesse di Walter Isaacson – autore di best-seller su grandi figure della scienza e della tecnologia – per Charpentier e Doudna, concretizzatosi nell’opera “The Code Breaker. Jennifer Doudna, Gene Editing and the Future of the Human Race” (Simon & Schuster, 2021). In esso, Isaacson ripercorre il percorso scientifico intrapreso da queste due ricercatrici, snocciolandolo in un thriller emozionante, i cui brevi capitoli si leggono come romanzi gialli. Il libro, tradotto in italiano dalla Mondadori con il titolo “Decifrare la vita” è stato insignito di numerosi premi – best bookdel Washington Post, del Time, del Smithsonian Magazine... – e rappresenta una lettura altamente consigliata in questo periodo estivo, soprattutto per le giovani donne che intendono lanciarsi nella ricerca scientifica. Il DNA è un sistema di immagazzinamento delle informazioni che permettono la costituzione di organismi capaci di auto-replicarsi. Per decifrare queste informazioni è necessario decriptarne il linguaggio, e quindi, capirne le parole e conoscerne l’alfabeto. Le lettere dell’alfabeto del DNA sono quattro e corrispondono alle basi azotate (nucleotidi) che si susseguono nel DNA stesso: adenina, citosina, guanina e tiamina (A, C, G e T). Le parole sono semplicemente la sequenza, più o meno lunga, di basi nucleotidiche adiacenti (per esempio, una G seguita da una A, poi da due T, poi da una C formano la parola GATTC, il cui senso vedremo fra poco). Poiché la DNA di esseri viventi complessi è una lunga serie, senza interruzioni, di miliardi di basi azotate, la sfida della sua decifrazione si rivela una sfida enorme. Metaforicamente parlando, quando il lavoro sul genoma iniziò sessant’anni fa, fu come entrare in una biblioteca contenente milioni di libri, gli uni incollati agli altri, e cercare di capire come fossero stati catalogati e di cosa essi trattassero.
Per avere una speranza di successo, bisognava semplificare il problema dividendo, senza danneggiarlo, il DNA in pezzi piccoli e maneggiabili. Ben presto, s’individuarono nei batteri degli enzimi che “ricombinavano” il DNA, tagliandolo e ricucendolo. Furono chiamati “restriction enzymes”, anche se il loro nome scientifico è desossiribonucleasi (appunto perché spezzano l’acido desossiribonucleico). Grazie a questi enzimi si incominciò a capire alcune funzionalità basilari delle sequenze di nucleotidi: alcune indicavano l’inizio delle parole, altre delle interruzioni, altre ancora la fine. Rimaneva però un ostacolo insormontabile. Gli enzimi di restrizione che furono scoperti per primi erano tutti “sito-specifici”, ossia: sapevano tagliare e cucire solo intorno a delle sequenze particolari del DNA (la EcoR1 dell’Escherichia coli tronca il DNA solo in prossimità della serie GATTC vista prima) e quindi, il loro uso era limitato ai pezzi di DNA contenenti tali siti.
Quindici anni fa circa, però, fu scoperta la cosiddetta quinta classe degli enzimi di restrizione; fra questi, una meraviglia della natura: il Cas9 del Streptococcus pyogenes. Il Cas9 non ricombina il DNA usando sempre uno stesso sito, ma usa un meccanismo molto complesso grazie al quale, una cosiddetta ‘guida’ gli indica dove tagliare e ricucire. Questo permette al batterio di eliminare dal suo proprio patrimonio genetico, senza deteriorarlo, quello dei virus che vi sia intrufolato. Doudna e Charpentier dimostrarono che sintetizzando appositamente una guida, il Cas9 tagliava e ricuciva il DNA accuratamente, secondo le indicazioni della guida stessa, fino a una sola base azotata, ossia a livello di una specifica lettera di una specifica parola di uno specifico libro, fra i tanti della biblioteca. Questa tecnologia fu battezzata CRISPR-Cas9 o CRISPR – si legge ‘crisper’ – deriva dall’acronimo dei punti di riferimento usati dalla guida che dirige il Cas9: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats.
Come lo racconta Isaacson, per raggiungere tale risultato fu necessario un lavoro titanico, costellato di delusioni e di speranze, di aggiustamenti di rotta e di conferme, di contrattempi e di balzi in avanti. Non mancarono neppure gelosie e piccolezze umane. Ma ancora più ardue saranno le questioni etiche sollevate da questa tecnica stupefacente. Grazie a CRISPR, non solo sarà possibile comprendere meglio le informazioni contenute nel DNA, ma anche correggerlo nei minimi dettagli e persino sintetizzarlo in maniera innovativa. I limiti dell’uomo nel capire il codice della vita sono stati spinti verso il nuovo orizzonte di modificarlo e di sintetizzarlo con efficienza ed esattezza; lo strumento disegnato per scoprire il senso dei libri contenuti nella biblioteca, ora potrà scriverne dei nuovi. Le malattie genetiche potranno essere risolte tagliando con un bisturi chimico il DNA difettoso (magari a livello dei gameti in modo che un nascituro non porterà i geni malati dei suoi progenitori) e delle forme di vita sintetica saranno possibili, sia ricombinando i geni di specie già esistenti, sia sintetizzandoli dei nuovi (creando esseri viventi chimerici, un cane con la vista penetrante di un’aquila o un’aquila con l’olfatto eccezionale di un cane).
La stessa Doudna espresse dubbi sull’uso della sua scoperta applicata agli umani, per poi fare pace con sé stessa, affermando che, poiché qualche volta la natura stessa si comporta in modo crudele, era ingiusto non intervenire per correggere alcune mutazioni genetiche particolarmente detestabili: «Non sono sicura che in medicina, si possa tracciare una chiara distinzione fra il naturale e l’innaturale; la ritengo una dicotomia azzardata per impedire che si alleviano sofferenze e disabilità». Solo il futuro dirà se gli uomini utilizzeranno CRISPR in modo morale, per ora sappiamo solo che se sono arrivati fin qui, lo devono all’intuito, alla competenza e alla determinazione di due donne straordinarie.
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLXIII, 2023, N.198 p. 6)