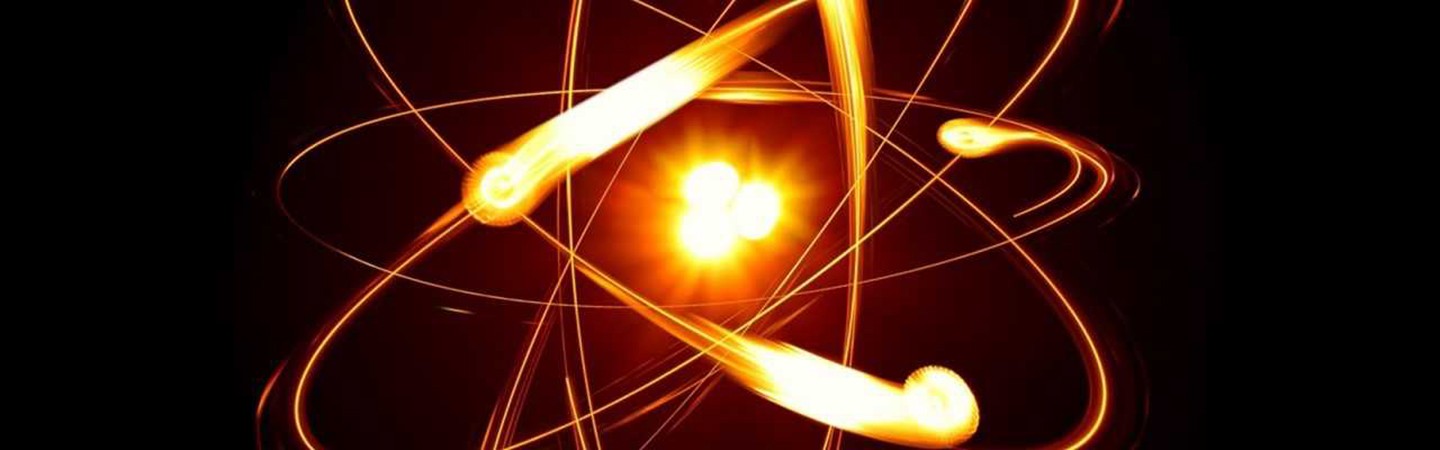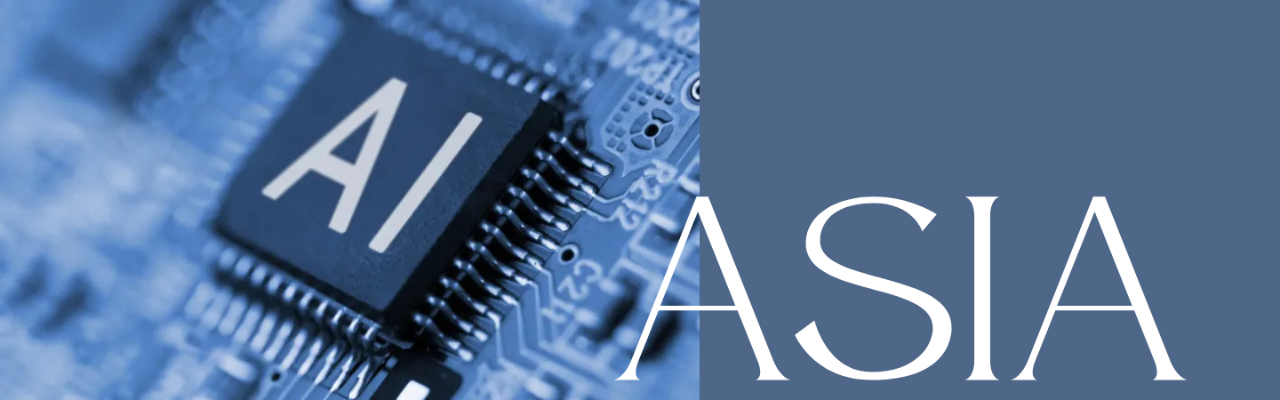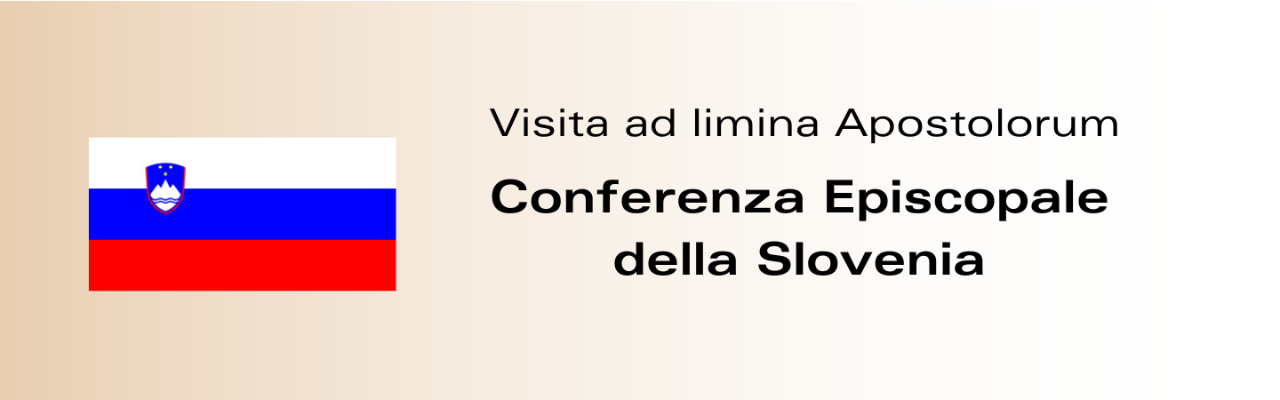Perfezionamenti sbalorditivi
I Premi Nobel scientifici 2023
di Carlo Maria Polvani
Gli appassionati di ippica conoscono bene i segreti delle andature del cavallo. Nel trotto, l’animale sposta le zampe secondo una cadenza simmetrica a due tempi; ma nel galoppo, il ritmo a tre o quattro tempi, diventa asimmetrico. Fino all’invenzione della macchina fotografica, molti si chiedevano se, in corrispondenza con la massima espansione della falcata di galoppo, le quattro zampe perdessero simultaneamente il contatto con il suolo. Quando furono inventati apparecchi capaci di scattare istantanee in rapida sequenza, si osservò che, per una frazione di tempo impercettibile all’occhio umano poiché inferiore a un trentesimo di secondo, i quattro zoccoli rimanevano discostati dal terreno, in corrispondenza però, della minima contrazione della falcata, ossia, quando le zampe dell’equino si trovavano raccolte sotto il suo corpo.
Questo aneddoto aiuta a capire la natura della scoperta ricompensata quest’anno con il Premio Nobel per la fisica. Essa riguarda il movimento degli elettroni che si verifica in intervalli di tempo dell’ordine di un miliardesimo di miliardesimo di secondo. Per concepire quando breve sia un “attosecondo” (10-18 s), si consideri che un solo secondo contiene un numero di attosecondi superiore al numero di secondi che sono passati sin dalla formazione dell’universo (13,5 miliardi di anni fa). Il francese Pierre Agostini e l’ungherese Ferenc Krauzs hanno appunto perfezionato dispositivi che producono raggi laser in sequenze di attosecondi per accertare gli spostamenti degli elettroni. I due scienziati hanno condiviso il premio con la francese Anne L’Huillier, poiché quest’ultima fu la prima ad osservare che alcune frequenze della luce potevano essere usate per identificare le posizioni di tali particelle subatomiche.
Anche nel caso del Premio Nobel 2023 per la chimica, tutto iniziò con un’osservazione sul comportamento degli elettroni irradiati dai corpuscoli che compongo la luce. Negli anni Ottanta, il russo Alexej Ekimov notò che i fotoni erano riflessi dal vetro in modi diversi a seconda della dimensione dei cristalli di dicloruro di rame contenuti nel vetro stesso. Poco dopo, lo statunitense Louis Brus, usando una soluzione liquida contenente dei cristalli della grandezza di un miliardesimo di metro (10-9 m), confermava le osservazioni di Ekimov e postulava che si potessero sinterizzare dei nano-cristalli atti a costituire dei cosiddetti “quantum dots”. I punti quantistici si chiamano così perché permettono agli elettroni di esprimere il loro potenziale quantistico, diventando dei veri e propri semi-conduttori. La ricerca del terzo laureato, il tunisino Moungi Bawendi, andò proprio in quella direzione. Tant’è che oggi, è prospettabile la fabbricazione di computer quantistici, che potrebbero avere una capacità computazionale enormemente superiore a quella degli attuali elaboratori elettronici a circuito integrato.
Le nano-molecole rivoluzioneranno probabilmente anche la farmacologia, quando, grazie a dei nano-vettori, si assicurerà la somministrazione selettiva di farmaci in alcuni tessuti del corpo, evitando quella sistemica. Per il 2023, però, il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato a due biochimici, lo statunitense Drew Weissman e l’ungherese Katalin Karikó, che hanno sviluppato le biotecnologie inerenti ai cosiddetti “vaccini mRNA”. La ricerca su questi ultimi incominciò intorno all’anno 2000 e fu sottoposta, per anni, a controlli sperimentali e a verifiche cliniche. La loro produzione su larga scala, però, fu assicurata nel 2020, in risposta alla pandemia da Covid-19.
D’altronde, anche la vaccinazione classica nacque nel contesto di una crisi pandemica virale, precisamente quella del vaiolo che, agli inizi dell’Ottocento, fu caratterizzata da un tasso di mortalità alquanto elevato. Il medico britannico Edward Jenner costatò che le mungitrici (il termine vaccino deriva appunto da vacca) che contraevano il vaiolo bovino (raramente letale per l’uomo) sembravano immuni da quello umano. Jenner prese del pus dalle pustole che piagavano le mani delle mungitrici contagiate dal vaiolo bovino e lo somministrò a un ragazzo sano, che risultò resistente al vaiolo umano.
I vaccini convenzionali che si svilupparono successivamente seguirono questa metodologia: iniettare un agente patogeno in forma attenuata o inattiva in un soggetto sano, in modo che il sistema immunitario di quest’ultimo produca anticorpi capaci di difenderlo da una possibile infezione dell’agente patogeno in pieno vigore. Per aumentare l’efficacia dei vaccini convenzionali e per ridurne gli effetti secondari, si lavorò per anni nella direzione di inoculare, al posto dell’agente attenuato o disattivo, unicamente una sua proteina caratteristica e, preferibilmente, innocua. Dopo la scoperta del DNA e del RNA, nacquero così i recombinant DNA vaccines e i mRNA vaccines. Nei primi, si isola la sequenza del DNA che codifica una proteina caratteristica del patogeno e si sintetizza in vitro tale proteina per poi iniettarla nel paziente; nei secondi, si isola il frammento di mRNA relativo alla proteina e lo si inietta nel vaccinato che la produce lui stesso; in entrambi i casi, il sistema immunitario del vaccinato riconosce tale proteina come un antigeno e produce gli anticorpi che, in caso d’infezione, osteggeranno il patogeno. Questi avanzamenti fanno sperare che, in futuro, i vaccini risultino ancora più performanti nella lotta contro le patologie infettive (in particolare, la malaria e la tubercolosi), diventino strumenti utili per contrastare certe malattie genetiche (in particolare, la fibrosi cistica e l’anemia falciforme) e siano persino utilizzati per curare alcune infermità molto diffuse (in particolare, i tumori e l’arteriosclerosi).
Le fotografie rimpiazzate dai laser, i microchip sostituiti dai nano-cristalli, i virus moribondi avvicendati da materiale genetico sono prove che il sapere scientifico progredisce grazie allo sviluppo di tecniche sempre più sofisticate. Il percorso di perfezionamento dalla scienza è progressivo, faticoso e difficoltoso poiché costellato da ritardi, sviato da false piste e condizionato da errori; ma rimane, indiscutibilmente, stupefacente.
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLXIII, 2023, N.241 p. 5)