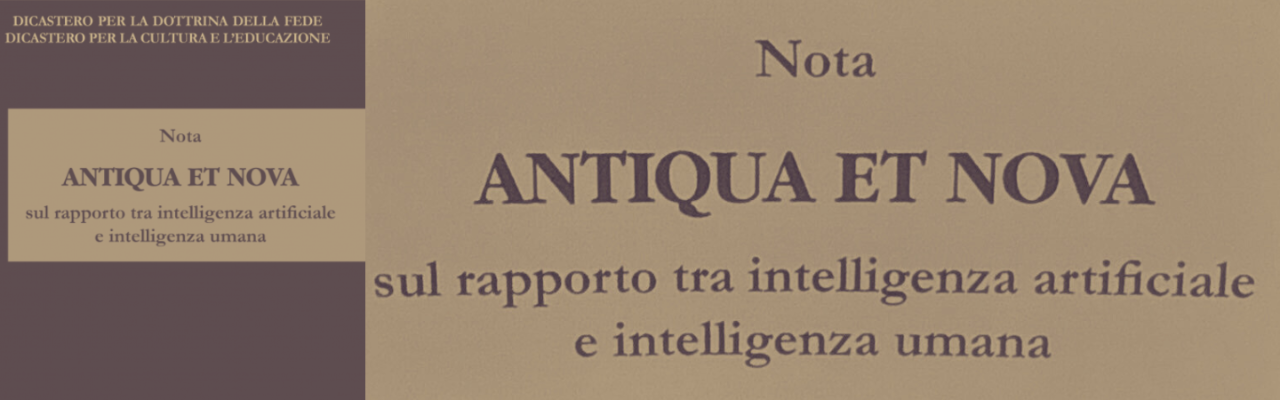Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana:
inaugurazione del XCVIII anno accademico
ALLOCUZIONE DEL GRAN CANCELLIERE
S.EM.R. IL SIG. CARD. JOSÉ TOLENTINO DE MENDONÇA
PREFETTO DEL DICASTERO PER LA CULTURA E L’EDUCAZIONE
Carissimo Rettore,
Carissimi Professori tutti
Carissimi Alunni,
Carissimi Collaboratori,
Illustri Invitati,
è per me una grande gioia, caro Prof. Stefan Heid, essere venuto qui oggi a celebrare con Voi l’inaugurazione del novantottesimo Anno Accademico del Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana.
Per un educatore come me, è sempre una grande emozione inaugurare un Anno Accademico; ma inaugurare l’Anno Accademico del Pontifico Istituto di Archeologia Cristiana ha, per me, un sapore molto particolare, direi privilegiato e unico. Ne ho avuto la conferma, questa mattina – e ve lo dico in tutta trasparenza – quando ci siamo riuniti nella magnifica Basilica di Santa Prassede per celebrarvi la Santa Messa, simbolo e perfetto memoriale della nostra identità cristiana.
La nostra identità cristiana, infatti, non si esaurisce unicamente nella storia, ma al contempo, essa non è mai separata dalla storia. Uno dei più importanti storici del XX secolo, Marc Bloch scrisse: «Altri sistemi religiosi hanno potuto fondare le loro credenze e riti su una mitologia quasi estranea al tempo umano. I cristiani, come Libri Sacri hanno invece dei libri di storia, e la loro liturgia commemora, con gli episodi della vita terrena di un Dio, i fasti della Chiesa e dei santi. […] Nella storia si svolge l’asse centrale di qualsiasi meditazione cristiana». L’Archeologia sacra, in sé stessa, rappresenta sia una testimonianza preziosa degli eventi storici che compongono l’affascinante e complessa marcia del cristianesimo nei secoli, sia, e forse soprattutto, una espressione della natura stessa del cristianesimo: realtà storica e, allo stesso tempo e proprio per mezzo della sua stessa storicità, realtà metastorica e trascendente.
Sono confortato in questa mia affermazione dalle stesse Sacre Scritture. Quando l’Apostolo Paolo visitò Atene (Atti 17) vi trovò «monumenti sacri» (sebâsmata) a profusione; ma, nel mezzo di tanta sovrabbondanza, fu colpito dall’altare portante l’iscrizione “Al dio ignoto” (Agnōstō Theô). Vi furono discussioni in merito all’esistenza di tale altare[1]. Ma che esso fosse esistito – come lo sostennero Pausania e Filostrato – o meno – come sostenne Diogene Laerzio – o, persino che il riferimento Paolino – come indicò san Girolamo[2] – derivò da una contrazione di un’intitolazione più lunga, permette di affermare con una certa sicurezza, che l’essenza dell’altare allo Agnōstō Theô che Paolo vide, era fondamentalmente la raffigurazione della cultura e del pensiero greco.
Nella dedica “Al dio ignoto”, dunque, non dobbiamo vedere unicamente una formula materiale, ma anche il ritratto profondo della “anima antica” , della anima umana con cui Paolo intense dialogare[3]. Per questo, nel discorso più famoso collocato da Luca sulle labbra di Paolo, è fuor di dubbio che esso vada classificato – con le parole di Martin Dibelius, come: «un discorso ellenistico sulla vera conoscenza di Dio»[4] – ma è anche fuori di dubbio che esso vada collegato con quanto Paolo ha, per esempio, affermato sulla conoscenza di Dio nella Lettera ai Romani. Il Dio che ha creato l’universo, e quanto esso contiene, è il Signore del cielo e della terra. La creazione, dunque, come l’Apostolo afferma in Romani 1,20, diventa un luogo possibile dal quale muoversi alla ricerca dell’«eterna potenza e divinità» di Dio.
La differenza tra Romani e Atti è essenzialmente stilistica: mentre nell’epistola Paolo si rivolge a un uditorio di cristiani, in grado di cogliere la tipica grammatica cristiana, nel discorso di Atene, Paolo si misura con una predicazione più trasversale e adatta a un pubblico culturalmente eterogeneo ma comunque di formazione neo-classica. Il contenuto della teologia paolina rimane però identico anche se la sua forma è stata strategicamente differenziata a seconda dell’uditorio. La storia è il luogo dell’incontro con Dio e di un incontro accessibile a tutti gli uomini, proprio nel loro contesto storico. Nel discorso agli ateniesi, infatti, San Paolo manifesta il suo convincimento che è possibile, per gli uomini, per tutti gli uomini, cercare Dio (At 17,27).
Il verbo greco che San Paolo utilizza, psēlafāo, significa “procedere per tentativi”, “cercare nel buio o nella semioscurità”. Voi, Cari amici, voi più di tanti, voi che conoscete perfettamente la pratica dell’archeologia, sapete bene il significato di questo verbo che collega la storia con la storia della salvezza. Oggi, la storia che stiamo vivendo fra crescere in noi tante preoccupazioni e tanta angoscia. Anche in questo caso, voi lo sapete bene, quando pensate agli scavi in Medio Oriente e la situazione drammatica di questa regione in questo momento.
Si apre un nuovo anno accademico. Si apre in un momento storico tragico. Ma la vostra vocazione di essere quelli che studiano la relazione della realtà storica – per quanto tragica essa sia – con la salvezza che ci viene da un Dio che per noi non è più ignoto – è sempre valido.
A voi studiosi tutti, ma soprattutto a voi ricercatori più giovani, auguro questo: essere fedeli eredi di una scienza che come nessuna altra celebra il rapporto indissolubile tra la storia e la salvezza. Contate su di me e su tutto il Dicastero, nell’aiutarvi a seguire questa vostra vocazione e siatene sempre fieri e orgogliosi.
[1] Cfr. J.A. FITZMYER, The Acts of the Apostles (New York: The Anchor Bible, 1998), 607.
[2] “Agli dèi dell’Asia, dell’Europa e dell’Africa, agli dei ignoti e a quelli stranieri”; Girolamo, In Titum, I,12 (P.L., XXVI, 572C-573A).
[3] É. Des PLACES, « Au Dieu Inconnu » (Act 17,23), in Biblica 40(1959), 797.
[4] M. DIBELIUS, Ursprung und Anfänge des Christentums, III (Stuttgart/Berlin, 1923) 105.