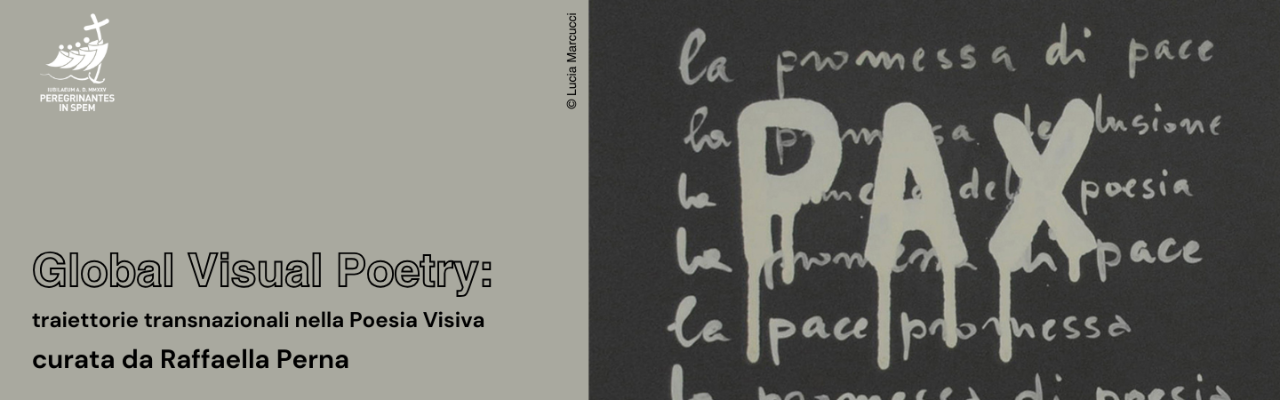Il gatto con gli stivali e il cane di Pavlov
Psicologia sperimentale
di Carlo Maria Polvani
I due alessandrini del teorico dell’estetica classica Nicolas Boileau (1636-1711) «Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément» («Ciò che si capisce bene s’esprime chiaramente e le parole per dirlo vengono facilmente») si applicano a meraviglia al libro di Adam Hart-Davis, Pavlov’s Dog, recentemente tradotto in francese dalla Larousse, sotto titolo Le Chien de Pavlov: 50 expériences qui ont révolutionné la psychologie. In esso, lo scientifico britannico introduce, in forma tanto ludica quanto efficace, il mondo della psicologia sperimentale, spiegando con parole cristalline i risultati di famosi esperimenti, pubblicati negli ultimi 100 anni, su rinomate riviste scientifiche.
Il Prof. Hart-Davis, per esempio, illustra le sperimentazioni per mezzo delle quali, George Sperling (1943-), ben prima che si usasse la risonanza magnetica per mappare le aree di attività celebrale, dimostrò l’esistenza delle due componenti della memoria iconica: la persistenza visuale e la persistenza informativa. Senza mai usare questi termini ma unicamente raccontando come delle linee di lettere di varie lunghezze (HSKYM o JTCRXFZV) erano mostrate per periodi di tempo diversi a dei soggetti, egli ci spiega che in 150 millisecondi, il cervello è capace di mantenere un’immagine di quanto percepito e poi di modificarla, secondo categorie prestabilite, per poterla immagazzinare. Ma la capacità del divulgatore inglese di esporre con parole accessibili degli esperimenti complessi è sola la prima qualità della sua opera.
La seconda risiede nel sapere delineare i quesiti soggiacenti agli esperimenti intrapresi. Nel 1963 – intrigato dalle parole di Lord Charles Percy Snow (1905-1980) «I crimini più odiosi sono stati commessi nel nome dell’obbedienza e non della ribellione» – Stanley Milgram (1933-1984) volle esaminare il conflitto fra coscienza e obbedienza. Il docente di Harvard chiese a dei volontari di partecipare a un gioco nel quale dovevano far imparare delle liste di nomi a degli alunni – che, all’insaputa del volontario, erano dei collaboratore di Milgram – seduti dietro un muro divisorio; ogni volta che gli alunni si sbagliavano, i volontari dovevano applicare la punizione di una scarica elettrica che, cominciando da valori molto bassi (15 volt), cresceva con il riprodursi degli errori. Se i volontari esitavano nell’eseguire la crudele sentenza perché sentivano le implorazione (simulate) dei loro alunni, Milgram li incitava a infliggere il sadico castigo con ordini sempre più perentori. Quasi due volontari su tre obbedirono, anche se controvoglia, al punto da infliggere scariche di livelli che pensavano potessero causare ferite gravi (500 volt)… cosa pensare, quindi, dei soldati tedeschi che, dopo la guerra, invocarono l’obbedienza militare per giustificare la loro collaborazione negli orrori nazisti?
La psicologia sperimentale spesso apre nuovi interrogativi quando cerca di risolverne dei vecchi. Lo dimostrano eloquentemente i lavori di uno dei padri della Gestaltpsychologie (“psicologia della forma”), Kurt Zadek Lewin (1890-1947) che, fuggendo dalla Germania hitleriana, si chiese se ci fossero predisposizioni innate per l’affermazione di un sistema democratico fra gli uomini.
Nel 1939, Lewin formò tre gruppi di preadolescenti, a cui fu dato il compito di collaborare insieme nella costruzione di un aeroplanino sotto la guida di un professore. Nel primo gruppo, i fanciulli erano inquadrati da un istitutore despotico che controllava tutto e tutti, punendo ogni trasgressione: il progetto avanzò ma non mancavano paure, sospetti e litigi. Nel secondo, i piccoli erano educati da un maestro che stimolava la libera espressione e la collaborazione: il progetto fu completato con successo, data l’armonia che regnava. Nel terzo, da un insegnante totalmente disinteressato che non interagiva con i piccini: il progetto non riuscì neppur a decollare, visto lo stato di anarchia che si era insediato. Cosa ben più notevole: il trasferimento dei bambini da un gruppo all’altro aveva poco effetto sull’esito finale, con i nuovi arrivati che si adattavano rapidamente al nuovo regime. Il libro di Hart-Lewis è quindi rinfrescante perché non entra nei principi teorici delle varie teorie psicologiche – come i principi di “totalità” o di “isomorfismo” sui quali si basa appunto la “psicologia della forma” – ma permette di apprezzare i dati empirici stessi che hanno dato vita a varie scuole di pensiero.
Si scopre così che il padre del behaviorismo (che pone come unico oggetto dello studio psicologico il comportamento in una determinata situazione) John B. Watson (1878-1958), nel 1920, dimostrò, con l’esperimento del Little Albert, che i principi di condizionamento evidenziati nel 1901 da Ivan Pavlov (1849-1936) nell’indurre un cane a salivare nell’aspettativa di cibo, si applicavano agli esseri umani. Si leggono poi gli esperimenti che, nel 1974, influenzarono la nascita della cognitive psychology (che studia primariamente come il nostro cervello elabora le informazioni). Elizabeth F. Loftus (1944-), per vagliare gli effetti della disinformazione, fece vedere un filmato di un’incidente automobilistico, chiedendo poi di rispondere a quesiti precisi su di esso; se al posto di chiedere «Avete visto il faro rotto?», chiedeva «Avete visto un faro rotto?», le risposte variavano sensibilmente. Daniel Kahneman (1934-) e Amos Tversky (1937-1996) proposero invece una breve descrizione di un personaggio domandando di determinare quale fosse la sua professione e osservarono che, nell’incertezza, la nostra mente funziona utilizzando meccanismi euristici di generalizzazione che lasciano spazio a errori di pregiudizio.
Insomma, quello che risulta accattivante in Pavlov’s Dog è l’accesso al dato sperimentale bruto. Alcuni dubitano della validità di questo approccio, visto che l’interpretazione di dati empirici non è sempre evidente. Come dimenticare il controverso esperimento con il quale, nel 1988, si osservò, a partire dal decorso post-operatorio di 393 pazienti dell’unità di malattie coronarie del San Francisco General Hospital, un effetto benefico della “preghiera d’intercessione”? Resta il fatto che alcuni risultati sperimentali non possono non colpire l’immaginazione. Sarah-Jayne Blakemore (1974-), Daniel Wolpert (1973-) e Chris Frith (1942), nel 2000, hanno disegnato un esperimento per investigare perché sia difficile farsi il solletico da soli. Dei soggetti valutano la sensazione di auto-solleticamento, muovendo con la mano destra un congegno che aziona delle piume sul palmo della mano sinistra; quello che non sanno è che un computer si accende ad intervalli di tempo irregolari, modificando leggermente la direzione del solletico che la mano destra decide di dare a quella sinistra. I soggetti dicono di sentire una piacevole sensazione, proprio quando il computer entra in azione. I tre ricercatori di Londra, Cambridge e Oxford ne deducono che quello che rende divertente il solletico è l’impossibilità di prevedere quale parte del corpo sarà stimolata, ed è per questo, che il solletico è piacevole solo quando viene fatto da un’altra persona. Da lì, l’idea di testare alcuni pazienti schizofrenici, riscontrando che questi ultimi trovano ugualmente piacevole l’essere solleticati o l’auto-solleticarsi.
Pur non sapendo quanto preoccupanti o rassicuranti debbano essere considerate tutte queste e ben altre osservazioni, andrebbe ricordato che il sullodato Boileau fu l’acerrimo oppositore di Charles Perrault (1628-1703; autore di tante fiabe oggetto di speculazioni psicanalitiche quali Cappuccetto rosso o La bella addormentata nel bosco) nella Querelle entre les anciens et les modernes. Uno dei nodi della famosa disputa del fine Seicento, era il determinare se nella rappresentazione – e quindi nella comprensione – della natura umana si dovessero seguire delle regole assolute o se si potessero collaudare delle innovazioni creative. La psicologia sperimentale sembra favorevole alla seconda proposizione, tant’è vero che la morale del Chat botté è proprio: «L’industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis».
(Da L’Osservatore Romano, Anno CLVI, 2016, N.196 p.5)