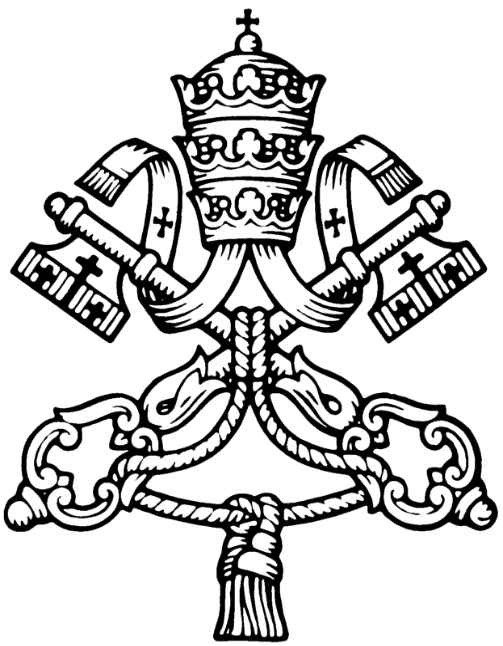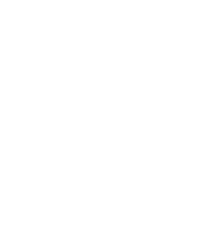La maturazione della fede: sfide e vie di crescita
IX Settimana di Studio per Formatori di Seminari
I. Introduzione: La geografia del cuore e la sapienza della soglia
Cari fratelli, cari amici, compagni in questo “pellegrinaggio dell’anima” che è la formazione presbiterale. Quando guardo questa assemblea, i miei occhi non vedono solo responsabili, delegati o direttori spirituali; vedo una vera e propria “geografia della speranza” che respira attraverso i polmoni di venticinque nazioni. Questa aula è un poliedro vivente dove le si intrecciano le voci del mondo.
Siamo un’icona della Chiesa universale, riuniti non per scambiarci protocolli amministrativi, ma per porsi in ascolto del battito cardiaco della vocazione sacerdotale. Siamo qui perché, pur parlando lingue diverse e provenendo da contesti culturali così distanti, siamo tutti abitati da un’unica, bruciante domanda: come si custodisce, come si alimenta e come si porta a maturazione il fuoco della fede nel cuore di un uomo chiamato a essere pastore in questo nostro tempo così complesso?
Il tema che ispira queste giornate ci viene consegnato con la nuda e tagliente precisione della Parola di Dio: «Chi non ha avuto delle prove, poco conosce» (Sir 34, 10). In un’epoca come la nostra, che sembra ossessionata dalla ricerca del successo immediato, dalla stabilità emotiva senza crepe e dall’efficienza tecnica, questa frase del Siracide suona quasi come una provocazione, se non come uno scandalo. Eppure, essa racchiude il segreto di ogni vera maturazione umana e spirituale. Già Atanasio di Alessandria affermava nella sua Vita di Antonio: «Nessuno che non abbia sperimentato le tentazioni potrà entrare nel regno dei cieli. Togli le tentazioni e nessuno sarà salvato!». Non c’è sapienza senza ferita, combattimento e maturazione; non c’è conoscenza autentica di Dio che non sia passata attraverso il “crogiuolo” dell’esperienza vissuta. La fede non è un’ideologia che si impara sui manuali, né una tecnica di gestione del sacro che si acquisisce con un addestramento burocratico; la fede è una relazione che si forgia nel tempo, e il tempo della fede è quasi sempre un tempo di attraversamento, un tempo di soglia.
Come formatori, il nostro compito non è quello di proteggere i candidati o i preti da ogni difficoltà, quasi volessimo creare per loro una “bolla” di asettica santità, ma di aiutarli a fare della prova il luogo teologico della loro crescita. Lo sottolinea Papa Leone XIV nella Lettera Apostolica “Una fedeltà che genera futuro”: «La fedeltà alla vocazione, soprattutto nel tempo della prova e della tentazione, si fortifica […] quando siamo capaci di ricordare con passione il suono della voce del Signore che ci ama, ci sceglie e ci chiama, affidandoci anche all’indispensabile accompagnamento di chi è esperto nella vita dello Spirito». Siamo qui per riflettere su come la fede matura, su come essa inciampa nelle insidie che la rendono fredda o rigida, e su come possa finalmente fiorire in una identità sacerdotale che sia, allo stesso tempo, profondamente umana e soprannaturalmente feconda.
II. L’archeologia dell’anima: Le stagioni del cuore presbiterale
La maturazione della fede non è un processo lineare, una sorta di ascesa trionfale e ininterrotta verso una perfezione astratta. È, piuttosto, un’archeologia dell’anima: un cammino di spoliazione, di scavo paziente, di continua riscoperta. Ogni sacerdote attraversa stagioni diverse, e ogni stagione ha il suo frutto specifico, la sua luce particolare, ma anche la sua tempesta necessaria. Permettetemi di usare un’immagine biblica che mi è cara: quella del cieco di Betsaida (Mc 8,22-26). Quando Gesù compie il miracolo della guarigione, non avviene tutto in una volta. Prima il cieco vede gli uomini “come alberi che camminano”, poi, con un secondo tocco di Gesù, vede chiaramente ogni cosa. Questa gradualità non è un fallimento del primo gesto di Cristo, ma una pedagogia: la vista, come la fede, matura per gradi.
La maturazione della fede è un processo che attraversa stagioni diverse, ciascuna con le sue caratteristiche, le sue opportunità, i suoi pericoli. Non possiamo pensare alla vita spirituale come prefabbricata: essa è coinvolta nella radicale singolarità di ogni soggetto. La vita spirituale ha bisogno di un volto e di un nome. Per questo, lungo il cammino della formazione – iniziale e permanente – dobbiamo riconoscere le diverse tappe di maturazione.
1. Il tempo del seminario: Il discernimento come “scuola dell’ascolto e del desiderio”
In questa prima fase, il giovane si avvicina al Mistero. Spesso è il tempo dell’entusiasmo primordiale, della “prima chiamata” che sembra risolvere ogni dubbio. Tuttavia, in questa fase la fede è spesso ancora molto “proiettiva”: il candidato rischia di amare l’immagine di sé come “salvatore” o l’immagine di un Dio che esaudisce automaticamente i propri bisogni di appartenenza. La prova qui è la pazienza del limite. Bisogna imparare che la vocazione non è un possesso psicologico, ma un’accoglienza ontologica. Il formatore deve accompagnare questo passaggio delicatissimo: dalla fede che “cerca garanzie e sicurezze” alla fede che “si fida del cammino nell’oscurità”. Scrive San Giovanni Della Croce: «…di notte andremo, senza luna / Senza luna andremo, senza luna / che per trovare la sorgente / basterà, a illuminarci, la nostra sete». Il desiderio si sveglia nella scuola dell’ascolto portando pazienza per tutto ciò che è irrisolto nel proprio cuore e che solo Cristo può chiarire e riscattare. Maturare in seminario significa accettare che non siamo noi i padroni della chiamata. Significa imparare a rivolgere il cuore nella direzione di Cristo, affidando a questa centralità cristologica la definizione del nostro camino.
2. Il nuovo sacerdote: L’apprendistato della realtà e dell’autonomia
L’ordinazione non è il traguardo, ma l’inizio di una nuova, feconda crisi. Il nuovo prete, uscito dalla protezione del seminario, deve imparare a gestire la propria autonomia davanti a Dio e davanti agli uomini. Spesso si scontra con una realtà pastorale che non corrisponde ai suoi schemi ideali. Qui la fede rischia di diventare “funzionale” o “prestazionale”. Il pericolo è che il ministero diventi un “fare” convulso che soffoca l’”essere”. La maturazione, in questi primi anni, passa per la capacità di restare ancorati a Dio nel segreto della propria stanza, anche quando la missione sembra assorbire ogni energia o, al contrario, quando sembra non dare alcun frutto visibile. È il tempo in cui si impara che il prete non è un “solista”, ma un uomo di comunione.
3. Il presbitero maturo: La lotta contro la monotonia e la mediocrità
Giunge poi la stagione della maturità cronologica, quella che spesso coincide con gli anni di mezzo della vita. È la tappa in cui si affacciano la monotonia, la stanchezza dei giorni che sembrano tutti uguali, e la sottile tentazione della “mondanità spirituale”. Qui la prova si fa quasi impercettibile: è la perdita del gusto per le cose di Dio, è l’accidia che San Tommaso definiva “tristezza per il bene spirituale”. Il sacerdote maturo si trova di fronte al bivio tra la mediocrità rassegnata e la santità quotidiana. La maturazione, in questo stadio, richiede un atto eroico di coraggio: il coraggio di ricominciare, di lasciare che la “memoria del primo amore” non sia un nostalgico rimpianto, ma una “fedeltà creativa”. Solo chi accetta di essere ancora una volta, a cinquant’anni o a settanta, un “discepolo alle prime armi”, può evitare di diventare un funzionario del sacro arido e spento.
III. Le insidie sul cammino: Le patologie che deformano il volto di Cristo
Lungo questo sentiero di crescita, la fede incontra delle ombre, delle derive che possono arrestarne il movimento vitale. Sono tentazioni antiche che si ripresentano oggi con vesti nuove, nate spesso dal desiderio inconscio di sfuggire alla nudità e all’incertezza del Vangelo.
1. Lo Gnosticismo: La fede come mero sapere intellettuale
È la prima grande sfida: trasformare il Mistero in un concetto, la Rivelazione in un sistema chiuso di informazioni. Quando la fede diventa gnosticismo, il sacerdote si sente superiore al Popolo di Dio perché lui possiede le chiavi di una conoscenza esoterica o accademica. Il presbitero formato in seminario ha studiato teologia, ha appreso le Scritture, conosce la dottrina. Tutto questo è necessario e buono. Ma quando la fede si riduce a sapere, quando il ministro si sente sicuro perché “sa le risposte”, qualcosa di essenziale si è perduto. La teologia, in questo caso, non è più una luce per i passi, ma un’arma di distinzione e di potere. Lo gnostico non ha bisogno della grazia, perché ha la sua dottrina; non ha bisogno degli altri, perché la sua mente basta a sé stessa. Ma una fede senza carne, senza contatto con le piaghe dell’umanità, non salva nessuno. Lo gnosticismo uccide la relazione. Crea distanza tra il ministro e il popolo di Dio. Il prete gnostico parla un linguaggio che nessuno capisce, propone una fede astratta che non tocca la vita concreta delle persone. Come scriveva Romano Guardini – un teologo che mi ha formato – l’ornamento è il veleno che uccide in noi l’espressione della verità. Allo stesso modo, la mera erudizione teologica, quando non è al servizio dell’incontro con Cristo, diventa un ornamento che impoverisce la fede invece di arricchirla. Come formatori, dobbiamo temere i candidati che hanno risposte pronte per ogni problema, ma che non hanno più una domanda che faccia tremare il loro cuore.
2. Il Sentimentalismo: L’idolatria del “sentire” e la fragilità emotiva
La seconda tentazione è opposta ma complementare: ridurre la fede a emozione, a esperienza emotiva. Viviamo in una cultura che privilegia il sentimento sull’intelligenza, l’immediatezza sulla profondità. Questa tendenza può penetrare anche nella vita di fede, generando una spiritualità fondata esclusivamente sulla “consolazione”, sul “sentire” la presenza di Dio.
Il prete che cade in questa tentazione cerca continuamente esperienze spirituali intense, cambia pratiche devozionali appena sente che “non funzionano più”, vive la preghiera come una ricerca di gratificazione emotiva piuttosto che come fedeltà nell’aridità. Quando la consolazione viene a mancare – e la tradizione spirituale ci insegna che verrà a mancare – la fede vacilla.
La maturità spirituale, al contrario, implica quella che i mistici chiamavano la “notte oscura”: la capacità di rimanere fedeli quando Dio sembra assente, quando la preghiera è arida, quando il servizio pastorale non produce frutti visibili. San Paolo testimonia questa verità paradossale: “Quando sono debole, allora sono forte” (2 Cor 12,10). La forza della fede non risiede nei nostri sentimenti, ma nella grazia di Cristo che opera anche – e forse soprattutto – nella nostra debolezza. Il più grande ostacolo alla vita di Dio dentro di noi non è la fragilità o la debolezza, ma la durezza e la rigidità. Non è la vulnerabilità, ma il suo contrario: l’orgoglio, l’autosufficienza, l’autogiustificazione. La sete, cioè il riconoscimento del nostro bisogno, ci umanizza e costituisce una via di maturazione spirituale.
3. Il Fideismo: La rinuncia all’intelligenza e al dialogo con il mondo
La terza tentazione è il fideismo: l’idea che la fede non debba dialogare con la ragione, che sia un salto nell’irrazionale, un abbandono del pensiero critico. Questa deviazione è particolarmente insidiosa perché si presenta spesso come umiltà (“ci si deve solo fidare”), ma in realtà nasce dalla pigrizia intellettuale o dalla paura del confronto.
Il fideismo porta a una fede infantile, non nel senso evangelico di “diventare come bambini”, ma nel senso di un rifiuto della maturità intellettuale. Il presbitero fideista non studia, non approfondisce, non si confronta con le domande del tempo presente. Si rifugia in formule che ripete senza comprenderle veramente, in pratiche che compie senza interrogarsi sul loro significato.
Una fede matura è una fede che pensa, che dialoga, che non ha paura delle domande. È una fede capace di abitare la complessità del reale senza semplificazioni ideologiche. Oggi abbiamo bisogno di uno sguardo disarmato e disarmante, capace non soltanto di annotare i dettagli ma di saper vedere l’interezza. Una delle urgenze delle nostre società è imparare di nuovo a vedere.
4. Il Fondamentalismo: La rigidità come maschera della paura
L’ultima tentazione che vorrei evidenziare è quella del fondamentalismo: la riduzione della fede a un sistema di regole rigide, la trasformazione del Vangelo in un codice di prescrizioni. Il presbitero fondamentalista ha risposte pronte per ogni domanda, certezze granitiche su tutto, un’ossessione per la purezza dottrinale che diventa giudizio impietoso verso chi non si conforma.
Il fondamentalismo nasce spesso dalla paura. Paura della complessità, paura del cambiamento, paura di perdere il controllo. In un mondo che cambia rapidamente, che pone domande nuove, che sfida le certezze tradizionali, il fondamentalismo offre l’illusione della sicurezza. Ma è una sicurezza pagata a caro prezzo: quella dell’irrigidimento, della chiusura, dell’incapacità di ascoltare.
Il fondamentalista dimentica che la fede è, anzitutto, relazione. Relazione con il Dio vivente, che sempre ci sorprende, che non si lascia rinchiudere nelle nostre categorie. Relazione con i fratelli e le sorelle, nella loro irriducibile diversità. Relazione con il mondo, che Dio ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito.
Come ho ripetuto spesso, la sorpresa è la firma di Dio nel tempo. Il Signore ci chiede di avere il coraggio dei nuovi inizi, di non adattarci a conoscere solo ciò che è stato, ma di abbracciare ciò che è. Dobbiamo allontanarci da ciò che è sempre ripetuto, dai giudizi meccanici che banalizzano la storia privandola di sorpresa e di speranza.
IV. Superare le sfide: vie di crescita e maturazione
Come aiutare i seminaristi e i presbiteri a superare queste tentazioni? Come favorire una vera maturazione della fede che integri conoscenza e relazione, ragione e cuore, fedeltà e creatività? Vorrei proporre alcune vie di crescita.
1. La via dell’integrazione: conoscenza che diventa sapienza
La prima via è quella dell’integrazione tra studio e vita. La teologia non è un sapere separato dalla vita, ma una luce che illumina l’esistenza concreta. Dobbiamo superare la falsa dicotomia tra formazione intellettuale e formazione spirituale, tra studio e preghiera, tra dogmatica e pastorale.
La formazione teologica nei seminari non deve produrre eruditi distaccati, ma pastori sapienti. La sapienza è quel sapere incarnato che nasce dall’esperienza, dal confronto con la vita reale delle persone, dalla fatica dell’accompagnamento. Come affermava Papa Francesco nel 2015, i preti non sono “funghi” che spuntano improvvisamente in cattedrale nel giorno dell’ordinazione: hanno una storia, provengono dal popolo, sono stati “presi fra gli uomini” per essere “costituiti in favore degli uomini”.
Questo significa che la formazione deve essere profondamente radicata nell’esperienza pastorale. Non basta studiare l’ecclesiologia: bisogna vivere la comunione ecclesiale. Non basta studiare la sacramentaria: bisogna celebrare i sacramenti con il popolo di Dio. Non basta studiare l’etica: bisogna confrontarsi con le situazioni concrete, con le scelte difficili, con le zone grigie dove non esistono risposte preconfezionate.
In questo processo, la letteratura può essere una risorsa preziosa. Nel fare teologia assistiamo sempre più, e con grande vantaggio, al ricorso alla letteratura, importante anche nella comprensione degli itinerari religiosi. Gli scrittori e i poeti sono maestri spirituali pertinenti e le opere letterarie possono essere di enorme utilità nel nostro cammino di maturazione interiore.
2. La via della vulnerabilità: dalla debolezza alla forza
La seconda via è quella di imparare a “bere dalla propria sete”. Questo significa riconoscere che proprio la nostra povertà è il luogo dove Gesù interviene. Serve tanto tempo per perdere la mania delle cose perfette, per vincere il vizio di sovrapporre alla realtà le false immagini.
I formatori devono aiutare i seminaristi e i giovani preti a non aver paura della propria fragilità, a non mascherarla dietro rigidità difensive o autosufficienze illusorie. Cristo ha voluto identificarsi con ciò che non amiamo di noi stessi, ha preso su di sé la nostra miseria e la nostra sofferenza. La grazia di cui necessitiamo non è nostra, ma di Cristo.
Questo ha implicazioni pratiche importanti per la formazione. Significa creare spazi di autenticità dove i seminaristi possano esprimere i loro dubbi, le loro fatiche, le loro paure senza timore di essere giudicati. Significa formare alla preghiera non come performance spirituale, ma come relazione onesta con Dio, capace di includere anche la lamentazione, la protesta, l’aridità.
Significa anche preparare i futuri preti alla inevitabile esperienza del fallimento: progetti pastorali che non funzionano, persone che non cambiano nonostante l’accompagnamento, situazioni che sembrano senza soluzione. La maturità non consiste nell’evitare il fallimento, ma nell’imparare a rimanere fedeli attraverso di esso.
3. La via del dialogo: fede che pensa e ragione che crede
La terza via è quella del dialogo tra fede e ragione, tra teologia e cultura. Dobbiamo contrastare le ideologie che “appiattiscono tutto” e uccidono la realtà, il pensiero, la comunità. Un cuore largo corrisponde a un’immaginazione e un pensiero di ampio respiro, mentre un pensiero rattrappito, chiuso e mediocre difficilmente può generare creatività e coraggio.
La formazione deve quindi educare al pensiero critico, alla capacità di discernimento, al dialogo con le scienze e le culture. Non possiamo formare preti che vivono in una torre d’avorio, isolati dal mondo contemporaneo. La Chiesa non deve isolarsi, non deve solo riprodurre pratiche e comportamenti, diventando custode del sacro, ma essere anche discepola, in un’esperienza che è in qualche modo nomadismo.
Questo significa che i formatori devono essi stessi essere aperti al dialogo, essere lettori del proprio tempo, essere capaci di costruire ponti tra la tradizione e le domande contemporanee. Significa valorizzare il contributo che i non credenti possono dare: anche loro, con la loro freschezza e il loro sguardo critico e libero, possono aiutarci a vedere aspetti della fede che l’abitudine ci ha reso invisibili.
4. La via della relazione: ministri come strumenti di Dio
I ministri sono strumenti di Dio, non protagonisti autonomi. Questa consapevolezza è fondamentale per superare le tentazioni che abbiamo descritto. Il presbitero non è un funzionario religioso, né un operatore pastorale, né un manager ecclesiastico. È un ministro ordinato, cioè uno che è stato costituito in un ordine, in una relazione particolare con Cristo e con il suo popolo. Come afferma Presbyterorum ordinis, i presbiteri “sono stati presi fra gli uomini e costituiti in favore degli uomini stessi nelle cose che si riferiscono a Dio”.
Questa identità relazionale ha conseguenze pratiche. Il prete non possiede la grazia che amministra: ne è servo. Non possiede la Parola che annuncia: ne è testimone. Non possiede il popolo che gli è affidato: ne è pastore al modo di Cristo. Ogni forma di appropriazione – della grazia, della Parola, del popolo – è una deviazione dall’identità ministeriale.
La teologia aiuta a distinguere, all’interno della missione della Chiesa, diversi momenti e modalità: il kerygma, cioè l’annuncio fondamentale della salvezza in Cristo; la catechesi, cioè l’educazione sistematica alla fede; l’evangelizzazione, cioè la testimonianza che rende presente il Vangelo in ogni ambiente; e la direzione spirituale, cioè l’accompagnamento personalizzato del cammino di fede.
Questa distinzione non è accademica, ma pastorale. Il presbitero deve saper discernere quando è il momento di annunciare, quando di insegnare, quando di testimoniare, quando di accompagnare. Non ogni situazione richiede la stessa risposta; non ogni persona ha bisogno dello stesso approccio. La maturità pastorale consiste anche in questa capacità di discernimento, che nasce da una solida formazione teologica unita a un’esperienza pastorale riflessa.
V. Dall’informazione alla formazione: un processo trasformativo
Infine, non basta trasmettere contenuti, per quanto corretti e importanti. La formazione è un processo che coinvolge tutta la persona, che trasforma non solo ciò che si sa, ma ciò che si è.
Questo richiede ai formatori un cambiamento di paradigma. Non possiamo pensare al seminario come a un’istituzione dove si impartiscono lezioni e si verificano conoscenze. Il seminario è, o dovrebbe essere, una comunità formativa dove si impara a vivere da discepoli di Cristo, dove si sperimenta la fraternità presbiterale, dove si viene iniziati progressivamente al ministero.
Come ha affermato Papa Leone XIV nella Lettera Apostolica “Disegnare nuove mappe di speranza”, educare è entrare in relazione. Una vera scuola – e a maggior ragione un seminario – non dovrebbe limitarsi a trasmettere in modo competente ed efficiente i diversi campi del sapere, ma prendersi cura di ogni persona nella sua unicità, aiutando ciascuno a vivere pienamente ciò che è. È necessaria una visione dialogica e integrale.
Questo processo formativo richiede tempo. Richiede pazienza. Richiede la capacità di accompagnare la persona nelle sue diverse stagioni, rispettando i ritmi di crescita di ciascuno. Come Gesù con il cieco di Betsaida, a volte è necessario un secondo tocco, una ripresa del cammino, un ritorno su temi già affrontati ma che ora possono essere compresi a un livello più profondo.
La formazione permanente, in questa prospettiva, non è un’appendice facoltativa alla formazione iniziale, ma parte integrante del cammino di maturazione. Il presbitero non finisce di formarsi il giorno dell’ordinazione: continua a crescere, a imparare, a maturare lungo tutto il corso della vita. Come ci ricorda il tema di questa Settimana di Studio, è proprio attraverso le prove che si approfondisce la conoscenza.
VI. Conclusione: la grazia dei nuovi inizi
Vorrei concludere questa riflessione tornando all’immagine da cui siamo partiti: il cieco di Betsaida che viene condotto fino a Gesù. Nessuno di noi può vedere da solo. Abbiamo bisogno di essere condotti, di essere accompagnati, di affidarci. E quando Gesù ci tocca, quando opera in noi, non tutto accade immediatamente. C’è una gradualità, una pedagogia divina che rispetta i nostri tempi.
Come formatori, siete chiamati a essere quelli che conducono i seminaristi fino a Cristo, che li accompagnano nel cammino di maturazione della fede. Non siete voi a operare la trasformazione – quella è opera di Cristo – ma siete testimoni e facilitatori del processo. È un compito umile, nascosto, come quello della luce che fa apparire le cose senza mettersi in mostra.
La maturazione della fede è un cammino che non finisce mai. Anche voi, formatori, siete in cammino. Anche voi avete bisogno di essere formati, di crescere, di attraversare le vostre prove. La vostra credibilità non nasce dal fatto di aver raggiunto una meta definitiva, ma dalla vostra fedeltà nel cammino, dalla vostra disponibilità a mettervi continuamente in discussione, dalla vostra apertura all’opera dello Spirito.
Vi auguro la grazia dei nuovi inizi. Non lasciatevi adattare a conoscere ciò che è stato: cercate di abbracciare quello che è. Allontanatevi da ciò che è sempre ripetuto, dai giudizi meccanici che banalizzano la storia privandola di sorpresa e di speranza. La sorpresa è la firma di Dio nel tempo.
Formate preti che non abbiano paura della propria sete, che sappiano riconoscere la propria povertà come luogo dell’intervento di Dio. Formate preti che pensano, che dialogano, che non si rifugiano in rigidità difensive. Formate preti che sono prima di tutto discepoli, sempre in ascolto, sempre in cammino, sempre disponibili a essere trasformati dall’incontro con Cristo e con i fratelli.
E ricordate: ogni teologia, ogni formazione, ogni ministero nasce dall’amicizia con Cristo e dall’amore per i suoi fratelli, le sue sorelle, il suo mondo. Questo mondo, drammatico e magnifico insieme, pieno di dolore ma anche di commovente bellezza. È a questo mondo, e per questo mondo, che formiamo i presbiteri del domani.
Grazie per il vostro servizio prezioso. La Chiesa ha bisogno di formatori sapienti, pazienti, coraggiosi. Prego perché il Signore vi sostenga in questo compito delicato e vi doni la gioia di vedere fiorire le vocazioni che vi sono affidate.
Card. José Tolentino de Mendonça