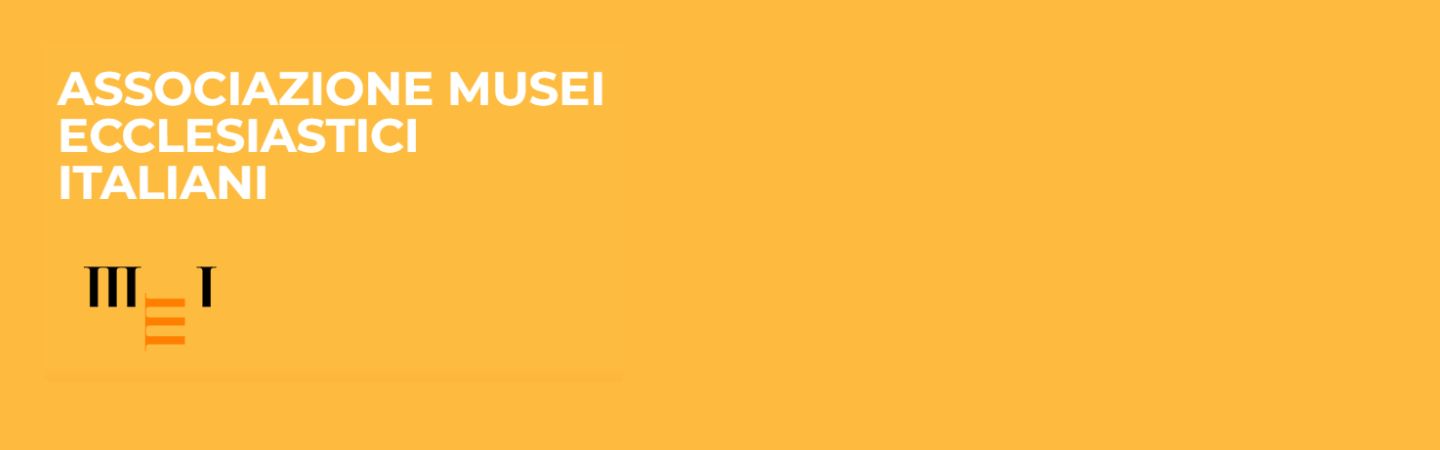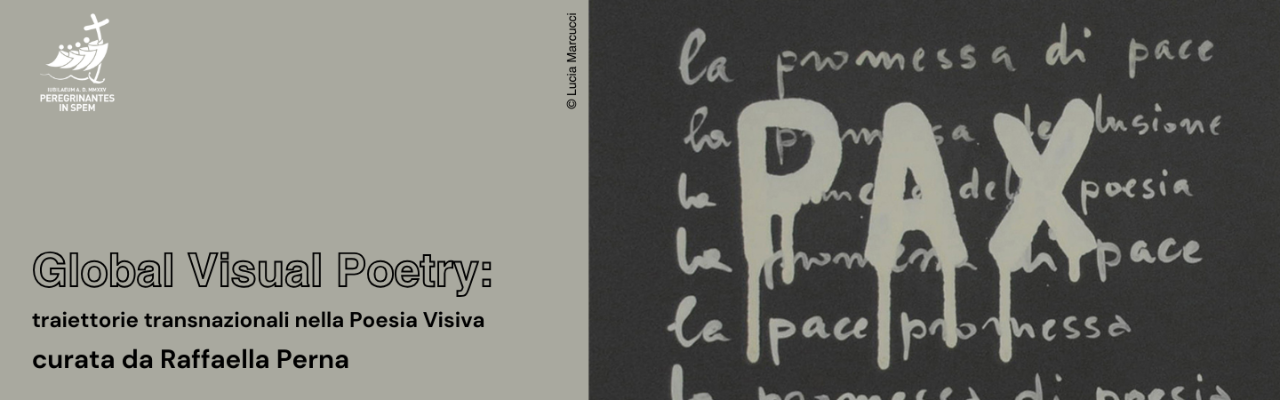Musei ecclesiastici come spazi dell’anima e laboratori di futuro
Saluti da Monsignor Paul Tighe all'Assemblea AMEI di Bologna
Monsignor Paul Tighe, Speaking Notes, Bologna, 24/11/2025
EVANGELIZZAZIONE ATTRAVERSO LA VIA PULCHRITUDINIS
Ieri sera, mentre venivo qui, sono passato sotto Orvieto. La cattedrale era illuminata e mi sono ritrovato attratto da una poesia intitolata “Seeing things” (Vedere le cose), in cui Seamus Heaney riflette sugli straordinari bassorilievi della facciata. È sopraffatto dai dettagli intricati e dalla delicatezza dell'opera, ma conclude:
“And yet in that utter visibility / The stone’s alive with what’s invisible.”
“E tuttavia, in quella assoluta visibilità, la pietra è viva di ciò che è invisibile”.
È una frase che descrive con precisione ciò che accade quando la bellezza diventa linguaggio spirituale: dentro ciò che è interamente visibile pulsa qualcosa che non si vede, ma che si lascia intuire.
Nel mondo dell’arte sacra — soprattutto nei musei ecclesiastici — questa verità diventa particolarmente eloquente: una pietra, una tavola dipinta, un’icona, un reliquiario non sono mai soltanto ciò che mostrano. Portano dentro una vita che non è immediatamente evidente, una presenza che attende di essere ascoltata. La via pulchritudinis nasce proprio dalla fiducia che l’invisibile è ancora vivo nelle forme del visibile, e che la missione della Chiesa passa oggi anche dal rendere questa presenza di nuovo riconoscibile.
Forse vi è capitato qualche volta davanti ad una scultura, ad un quadro, ad alcuni versi di una poesia, o ad un brano musicale, di provare un’intima emozione, un senso di gioia, di percepire, cioè, chiaramente che di fronte a voi non c’era soltanto materia, un pezzo di marmo o di bronzo, una tela dipinta, un insieme di lettere o un cumulo di suoni, ma qualcosa di più grande, qualcosa che “parla”, capace di toccare il cuore, di comunicare un messaggio, di elevare l’animo. Un’opera d’arte è frutto della capacità creativa dell’essere umano, che si interroga davanti alla realtà visibile, cerca di scoprirne il senso profondo e di comunicarlo attraverso il linguaggio delle forme, dei colori, dei suoni. L’arte è capace di esprimere e rendere visibile il bisogno dell’uomo di andare oltre ciò che si vede, manifesta la sete e la ricerca dell’infinito. Anzi, è come una porta aperta verso l’infinito, verso una bellezza e una verità che vanno al di là del quotidiano. E un’opera d’arte può aprire gli occhi della mente e del cuore, sospingendoci verso l’alto. (Benedetto XVI, Udienza Generale, agosto 2011.)
Viviamo in un mondo che vede moltissimo, ma che fatica sempre più a guardare davvero. Le immagini sono ovunque: scorrono rapide, si sovrappongono, ci raggiungono in un flusso continuo. Eppure, raramente accade che una di esse ci tocchi nel profondo. Lo sguardo — quello vero, attento, trasformativo — è diventato un atto raro. Ecco perché la via pulchritudinis non è un tema secondario, ma un’urgenza pastorale e culturale: ci invita a imparare di nuovo a vedere, a recuperare quel tipo di sguardo capace di accorgersi che “la pietra è viva di ciò che è invisibile”.
È bello riconoscere che, quando la lanterna magica del cinema si accende nel buio, s’infiamma in simultanea lo sguardo dell’anima, perché il cinema sa associare quello che sembra essere soltanto intrattenimento con la narrazione dell’avventura spirituale dell’essere umano. Uno dei contributi più preziosi del cinema è precisamente quello di aiutare lo spettatore a tornare in sé stesso, a guardare con occhi nuovi la complessità della propria esperienza, a rivedere il mondo come se fosse la prima volta e a riscoprire, in questo esercizio, una porzione di quella speranza senza la quale la nostra esistenza non è piena. Mi conforta pensare che il cinema non è soltanto moving pictures: è mettere in movimento la speranza! (Leone XIV, Incontro con il Mondo del Cinema, novembre 2025.)
1. La bellezza come linguaggio di Dio e soglia dell’invisibile
La Bibbia ricorda che Dio vide ciò che aveva creato ed era cosa “molto buona”. In ebraico tov significa allo stesso tempo “buono” e “bello”: la bellezza, dunque, non è un ornamento, ma la firma stessa del Creatore, l’armonia che trapela dal reale. È un linguaggio originario, che precede la parola e la supera.
San Tommaso d’Aquino descrive la bellezza come ciò che “piace quando è visto”. Ma questo “piacere” non è superficiale: indica la consonanza profonda che si crea quando la verità e il bene si manifestano in una forma armoniosa. La bellezza è una via privilegiata di conoscenza perché non argomenta: attrae. Non impone: invita. È un ponte tra il visibile e l’invisibile, uno spazio dove il mistero si avvicina senza far rumore.
Proprio per questo, la bellezza ha un potenziale evangelizzatore straordinario. Oggi, quando molte parole della fede sembrano non risuonare più nel cuore dei nostri contemporanei, la bellezza continua a parlare con una freschezza sorprendente. È capace di raggiungere persone lontane, ferite, disilluse. È un linguaggio universale che cerca la parte più umana dell’uomo, e che spesso la trova.
Eppure, questa relazione tra visibile e invisibile non è sempre evidente. Per molti, entrare in un museo ecclesiastico significa contemplare opere splendide, ma talvolta percepite come mute. In un incontro a Parigi dedicato al patrimonio religioso europeo, mi venne spontaneo chiedere — e chiedermi —: “Dio abita ancora qui?” Non come provocazione, ma come consapevolezza del fatto che molti visitatori avvertono una distanza: la porta è aperta, ma la casa sembra buia.
È una condizione che Heaney descrive con un altro suo verso folgorante: “The door was open and the house was dark.” La porta è davvero aperta: i nostri musei sono accessibili, le opere sono custodite con cura, il pubblico è numeroso. Ma la “casa” — lo spazio interiore del significato, della presenza — talvolta rimane avvolta nell’oscurità. Il nostro compito è proprio questo: aiutare i visitatori a non fermarsi sulla soglia, a non temere l’oscurità, a scoprire che proprio lì può accendersi una luce. E che quella luce è ancora capace di rivelare, con discrezione, una Presenza.
2. La bellezza come esperienza di incontro e come responsabilità condivisa
Papa Francesco ci aveva ricordato che l’evangelizzazione non è mai imposizione, ma incontro. La via pulchritudinis è uno dei modi più limpidi per rendere possibile questo incontro, perché nasce dalla gratuità. L’arte, diceva il Papa, “non spiega, ma evoca”: e nell’evocare apre un varco, crea uno spazio di ascolto, mette in moto una domanda.
Nei musei ecclesiastici può accadere qualcosa di prezioso: chi entra come turista può uscire come pellegrino. Non perché abbia ricevuto una lezione esplicita, ma perché un dettaglio, un colore, un volto lo ha toccato. Nella gratuità della bellezza nasce una forma di ascolto che non può essere programmata, ma che può essere preparata.
Perché questo accada, però, è necessario un cambiamento di prospettiva. Il patrimonio religioso non è un “bene da possedere”: è una eredità da condividere. Ogni opera porta con sé quella che potremmo chiamare — come ricordavo a Parigi — una social mortgage, un’“ipoteca morale”: appartiene alle generazioni passate, ma anche a quelle future. Custodirla significa permettere che continui a generare vita, incontro, significato.
Per questo non basta proteggere le opere: occorre creare le condizioni affinché esse continuino a parlare. L’evangelizzazione attraverso la bellezza non aggiunge un messaggio alle opere, ma libera il messaggio che è già presente in esse. Aiuta a scorgere l’invisibile che le abita. Torna qui il verso di Heaney: la pietra è viva, anche se non sempre sappiamo vederlo.
3. Sharing Hope – Horizons for Cultural Heritage
Nel contesto del Giubileo per gli Artisti e il Mondo della Cultura, il Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in collaborazione con i Musei Vaticani, ha organizzato nello scorso febbraio 2025 un incontro per i responsabili di musei e gli operatori nel mondo dell’arte e accademico e delle istituzioni culturali, dal titolo “Sharing Hope – Horizons for Cultural Heritage”, al fine di favorire una riflessione sulle attuali possibilità, modalità e linguaggi per la promozione e la trasmissione del patrimonio religioso e artistico. Al termine dell’incontro, alla presenza di stakeholder internazionali, è stato presentato un manifesto educativo sulla trasmissione del codice culturale delle religioni, di cui sono state distribuite copie ai presenti.
Nel discorso di presentazione il prefetto del Dicastero, Card. José Tolentino de Mendonça ha detto: Sappiamo tutti quanto l’attività culturale è stata ininterrottamente fecondata dal codice delle religioni. In effetti, senza questa chiave culturale, i grandi musei nazionali diventerebbero un arsenale di oggetti di scarsa lettura e un intero patrimonio umano sarebbe a rischio. […] Non conoscere il codice culturale religioso non è soltanto una carenza dal punto di vista religioso: è anche una carenza culturale e di civiltà, perché significa perdere di vista una parte decisiva dell’orizzonte nel quale storicamente siamo inseriti.
Così nel Manifesto tutti i sottoscrittori, «direttori, curatori e rappresentanti delle maggiori istituzioni museali» del mondo si sono impegnati «nella promozione del patrimonio culturale religioso come codice universale di speranza, dialogo e riflessione». Essi si sono impegnati di farsi interpreti della trasmissione e reinterpretazione dei significati profondi del patrimonio religioso e artistico religioso soprattutto nei confronti delle giovani generazioni, attraverso 7 punti:
1. Accessibilità e comunicazione: attraverso l’uso delle nuove tecnologie, familiari ai giovani
2. Sostenibilità culturale: rispetto della natura, della cultura dei popoli da cui provengono i manufatti (“decolonizzazione”), delle diversità culturali (comunità locali)
3. Inclusione e innovazione nei linguaggi culturali: impegno a dare un contenuto solido alle narrazioni divulgative attraverso le nuove tecnologie
4. Consapevolezza e ricontestualizzazione: riconduzione di ogni manufatto al proprio contesto originario (etnico, religioso ecc.)
5. Intelligenza artificiale e digitalizzazione come ponti verso il futuro: reinterpretare creativamente il patrimonio
6. Educazione per un coinvolgimento profondo e sostenibile: importanza dell’educazione anche per la riscoperta dei valori profondi del patrimonio e di iniziative rivolte ai giovani
7. Custodia e trasmissione in tempo di crisi: di fronte alle sfide del nostro tempo (inquinamento, cambiamento climatico, conflitti), i giovani sono protagonisti e non solo fruitori della trasmissione del patrimonio.
4. Sintesi della missione - accessibilità, sostenibilità culturale, inclusione
La responsabilità condivisa di aprire nostro patrimonio con le generazioni futuri passa per tre parole chiave: accessibilità, sostenibilità culturale, inclusione.
Accessibilità
Non significa soltanto abbattere barriere architettoniche o linguistiche, ma aprire percorsi interiori. Tradurre senza tradire: accompagnare senza semplificare. Il vero accesso non è quello che conduce davanti all’opera, ma quello che permette all’opera di entrare nel visitatore.
Oggi, nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale o la realtà aumentata possono diventare strumenti di accessibilità all’opera. Non sostituiscono la visita fisica né l’incontro reale con l’opera, ma possono aprire ponti verso nuove forme di conoscenza e partecipazione. L’importante è che la tecnologia resti umana: che non spenga l’emozione, ma la accenda; che non isoli, ma colleghi: “Nessun algoritmo potrà sostituire la poesia, l’ironia e l’amore” (papa Francesco). Un museo ecclesiastico deve custodire la relazione, non surrogarla.
Sostenibilità culturale
Custodire il patrimonio religioso significa custodire anche il contesto che lo ha generato — la terra, le comunità, i riti, le lingue. Ogni oggetto sacro è parte di un ecosistema di fede, un intreccio di memoria e natura. Un museo ecclesiastico è chiamato a essere ecologicamente e spiritualmente sostenibile: rispettoso della materia e della storia, aperto a una “conversione ecologica” della cultura.
Inclusione
In questo orizzonte, la inclusione diventa il linguaggio della speranza. Le nuove generazioni, le minoranze culturali, le persone lontane dalla fede devono sentirsi accolte, non giudicate. La bellezza è un luogo ospitale. L’arte sacra nasce dall’incontro tra popoli, epoche, stili, e proprio per questo insegna a convivere nella differenza. I musei ecclesiastici possono diventare “spazi di fraternità estetica”, dove il visitatore non si limita a guardare, ma partecipa, si riconosce, si lascia toccare.
Ma includere non significa semplificare. È necessaria una profonda consapevolezza del contesto originario delle opere, per non ridurre il sacro a pura estetica. Il museo deve restituire le opere al loro significato integrale, al loro respiro teologico, al vissuto delle comunità che le hanno generate. Questa ricontestualizzazione non è un’operazione museografica, ma un atto di giustizia culturale e spirituale: permette di vedere nelle opere non solo manufatti del passato, ma testimonianze vive di fede e di umanità.
5. La bellezza che ferisce, salva e ricrea: il cuore cristiano della via pulchritudinis
Il cristianesimo ha reinventato la bellezza: l’ha resa paradossale.
La bellezza del Crocifisso — del Cristo “senza apparenza né bellezza” secondo Isaia — è una bellezza che nasce dal dono, non dall’apparenza. L’iconografia di Grünewald a Colmar è forse il suo esempio più drammatico e più eloquente: un corpo piagato, sfigurato dal dolore, diventa rivelazione di un amore che salva.
Questa bellezza è tutt’altro che accomodante: inquieta, ferisce, scuote. Non è equilibrio, ma armonia che nasce dal disordine. È la bellezza che non anestetizza, ma risveglia; che non consola soltanto, ma apre alla trasformazione. È una bellezza che porta dentro una ferita perché porta dentro una promessa.
Nei musei ecclesiastici questa bellezza assume un valore particolare. È una bellezza incarnata: fatta di materia, di storia, di mani che hanno plasmato, di comunità che hanno pregato. È una bellezza che parla di fragilità e di speranza, di morte e di resurrezione, di caduta e di rinascita. In essa il visitatore può percepire che l’invisibile non è un’astrazione, ma una presenza concreta. E proprio qui torna ancora una volta il verso di Heaney: in quella assoluta visibilità, la pietra è viva dell’invisibile.
Il Crocifisso, l’icona, l’affresco non sono soltanto ciò che mostrano: sono ciò che evocano. Sono visibili, eppure “vivi” di una vita che non si lascia delimitare. Il loro compito non è soddisfare il nostro sguardo, ma aprirlo; non è offrire risposte, ma generare domande.
In un tempo di crisi globale – guerre, migrazioni, mutamenti climatici – i musei ecclesiastici possono diventare spazi di resilienza e di speranza. La bellezza che custodiscono è una forma di resistenza al male: è la testimonianza che, anche nei periodi più oscuri, l’uomo ha continuato a creare, a pregare, a credere. I giovani devono essere coinvolti non solo come visitatori, ma come custodi attivi di questo patrimonio. È loro la missione di trasmettere una bellezza che non è evasione, ma impegno, non è possesso, ma promessa.
Il museo non è solamente un archivio del passato, ma officina del futuro; non spazio neutro di esposizione, ma luogo di dialogo e di discernimento; non tempio della memoria, ma scuola di umanità. È questo il nuovo volto dell’evangelizzazione attraverso la via pulchritudinis: mostrare che ogni opera d’arte sacra è una parabola ancora aperta, una domanda ancora viva, una chiamata alla speranza.
Dopo aver citato l'opera di Grunewald a Colmar, non posso non ricordare la presenza, in realtà alquanto anacronistica, di Giovanni Battista nella scena della Crocifissione nella pala d'altare di Isenheim. In quell'immagine, ciò che cattura l'attenzione dello spettatore è l'indice sproporzionatamente grande del Battista che indica Cristo. Questa immagine potrebbe anche servire come simbolo del ruolo dei musei ecclesiastici nell'aprire una strada verso l'incontro con Cristo. Si tratta di una missione da intraprendere con sottigliezza e delicatezza, un invito piuttosto che un'imposizione. Non possiamo semplicemente bombardare le persone con le nostre “risposte”, ma dobbiamo prendere sul serio le loro domande e permettere loro di esprimersi pienamente. Un modo particolarmente significativo per offrire tale testimonianza sarà attraverso la disponibilità a donarsi agli altri, affrontando con pazienza e rispetto le loro domande e i loro dubbi mentre avanzano nella loro ricerca della verità e del significato dell'esistenza umana (Papa Benedetto, Messaggio WCD, 2013).
6. Andare in Chiesa / Church Going (1954) Philip Larkin (Jacopo Masi)
Vorrei aggiungere una nota di speranza. Le persone che varcano la vostra soglia arrivano come turisti, spesso curiosi ma poco informati. Entrano in contesti che per loro sono strani. Mi viene in mente la meravigliosa poesia di Philip Larkin “Church Going” (Andare in chiesa). Larkin descrive la sua reazione mentre visita una vecchia chiesa. Si presenta come un non credente che non sa bene come comportarsi in questo ambiente insolito... Hatless, I take off my cycle-clips in awkward reverence …Senza cappello, tolgo con un gesto di goffa riverenza le mollette da bici. Conclude la sua visita affermando che non valeva la pena fermarsi... Back at the door, I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for …. All’uscita firmo il registro, lascio un mezzo scellino irlandese in offerta. Il posto, mi dico, non valeva la sosta. Riconosce, tuttavia, che spesso si ferma alle chiese e si chiede perché lo fa e si chiede se in futuro le chiese saranno completamente abbandonate, tranne alcune che potrebbero fungere da musei.
What we shall turn them into, if we shall keep
A few cathedrals chronically on show,
Their parchment, plate and pyx in locked cases,
And let the rest rent-free to rain and sheep.
quando saranno tutte
cadute in disuso, se manterremo
qualche cattedrale in cronica mostra,
le pergamene, gli argenti e la pisside
in teche protette e il resto ceduto
in uso gratuito a pecore e pioggia.
La conclusione della sua poesia è piuttosto inaspettata, poiché egli insiste sul fatto che le chiese attireranno per sempre visitatori, visitatori sorpresi dal loro bisogno di essere più seri.
A serious house on serious earth it is,
In whose blent air all our compulsions meet,
Are recognised, and robed as destinies.
And that much never can be obsolete,
Since someone will forever be surprising
A hunger in himself to be more serious,
And gravitating with it to this ground,
Which, he once heard, was proper to grow wise in,
If only that so many dead lie round.
Una dimora seria su una terra
seria è questa; qui, in un’aria composita,
i nostri impulsi si incontrano, sono
riconosciuti e ammantati di un’aura
di destino. E tutto ciò mai potrà
essere obsoleto poiché qualcuno
sempre sorprenderà una brama in sé
di essere più serio e, assieme, un richiamo
a gravitare verso questo suolo
adatto, gli giunse voce, a far crescere
in saggezza, se non altro per tutti
questi morti che giacciono qui attorno.
Teniamo le nostre porte aperte ai “ricercatori”, a coloro che vogliono essere più seri, a coloro che, nelle parole di Peter Berger, hanno sentito “il rumore degli angeli”. Cerchiamo di vedere la loro potenziale presenza in ogni persona che varca la nostra soglia.
7. Musei ecclesiastici come spazi dell’anima e laboratori di futuro
Alla luce di tutto questo, possiamo dire che i musei ecclesiastici non sono semplici luoghi di esposizione: sono spazi dell’anima, luoghi dove il tempo rallenta e il silenzio parla. Nella cultura della fretta offrono pause; nella cultura della frammentazione offrono continuità; nella cultura del consumo offrono gratuità.
Sono luoghi dove l’uomo contemporaneo può ancora percepire l’eco del divino. Non perché sia costretto, ma perché è invitato. Non perché riceve una lezione, ma perché sente una risonanza. Qui la bellezza non divide, ma unisce; non impone, ma accompagna; non chiude, ma apre.
Per questo i musei ecclesiastici sono destinati a diventare sempre più — e sempre meglio — officine di futuro. Spazi di dialogo, di discernimento, di ricostruzione culturale e spirituale. Non templi della memoria, ma scuole di umanità. Non archivi del passato, ma generatori di senso.
In un mondo dove l’uomo rischia di sostituire Dio con sé stesso — come profetizzava Dostoevskij nel passaggio dal “Dio-uomo” all’“uomo-Dio” — la via della bellezza rimane un varco prezioso. È attraverso la bellezza che il sacro può tornare a essere percepito, riconosciuto, desiderato. È attraverso la bellezza che possiamo ricordare al mondo che l’invisibile non è scomparso: è semplicemente in attesa di essere visto.
E così, anche noi, nel nostro lavoro quotidiano, possiamo continuare a ripetere con Heaney: “And yet in that utter visibility / The stone’s alive with what’s invisible.” “E tuttavia, in quella assoluta visibilità, la pietra è viva di ciò che è invisibile”. Perché di questo abbiamo bisogno: di mostrare al mondo che dentro la materia dell’arte, dentro le pietre delle nostre chiese, dentro le storie dei nostri popoli, c’è ancora una vita che vibra, una Presenza che parla, un futuro che si apre.
La porta è ancora aperta. La casa non è così buia come sembra. E la bellezza — quella vera, quella che salva — continua a essere la nostra guida.